Dal'oligarchia nasce il cannibalismo politico - Seconda parte
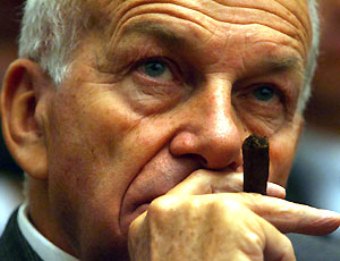
Seconda Parte
di Fausto Bertinotti
Il processo costituente del capitalismo finanziario europeo
Intanto la fissità del timone di comando sulle politiche di austerità si consolida e si allarga nei governi europei. Ultima, ma assai significativa, è stata l’adesione dichiarata e aperta della Francia di Hollande. Il governo di Hollande, su cui si erano malamente appuntate le speranze di chi riteneva che il centrosinistra europeo potesse farsi diverso da quello che è, aveva dato cattiva prova di se e smentito ogni aspettativa di modifica delle politiche del precedente governo di Sarkozy. Le elezioni parziali successive alla sua vittoria elettorale avevano già condannato pesantemente lui e il Partito socialista fino all’impressionante ascesa del Front National di Marine Le Pen, ma Hollande era stato recalcitrante a scegliere fino in fondo le politiche di austerità, la ricetta propugnata anche in Francia dalla destra. Il discorso di Hollande di fine anno e la conferenza stampa che l’ha seguito hanno fatto anche l’ultimo passo, proclamando l’adesione del suo governo alle dottrine e alle scelte neoliberiste.
La destra, persino un po’ spiazzata, prima ha taciuto, poi ha applaudito. La rivista conservatrice Le Point gli ha dedicato quasi l’intero numero per sottolineare l’importanza dell’evento: todos caballeros. Il suo direttore, Franz Olivier Giesbert, ha detto: “Il suo sostegno alle imprese e all’economia rappresentano una svolta storica per la gauche. Sono molto colpito. E' un cambio d’epoca. Finalmente la sinistra francese entra nel ventunesimo secolo”.
Il fronte dei governi che sceglie la ristrutturazione dell’economia capitalistica per farne la spina dorsale dell’Europa reale, una costituente contro la società e ciò che è stata chiamata la civiltà europea, si allarga e si consolida. Il prezzo sociale che i popoli europei pagano crescentemente è senza precedenti. In particolare nei Paesi dell’Europa mediterranea la crisi economica è ormai una profonda crisi della coesione sociale. I livelli di disoccupazione sono diventati socialmente insostenibili. Le povertà divorano parti della società che mai le avevano conosciute e da cui si erano convinte storicamente di esserne estranee. Ma, in Italia, a disegnare il carattere di classe della riorganizzazione dell’economia in atto c’è il fatto incontrovertibile che aumentano i poveri, ma, contemporaneamente, aumentano pure i ricchi. Nel 2012, ultimo anno a disposizione per questi dati, i ricchi il cui patrimonio stimato supera il milione di dollari sono aumentati di centoventisettemila unità, tanti quanti gli abitanti di una media citta. I milionari d’Italia, in un anno centrale della crisi, sono dunque aumentati di circa del 10% e tra loro i più lo sono diventati perché è salito il valore del loro patrimonio investito in titoli e azioni.
Non c’è nulla di innocente in tutto ciò. Sono state le banche centrali che, con le loro azioni, hanno fatto crescere Borsa e prezzi dei bond, sicché chi aveva patrimoni si è arricchito, mentre a scendere erano i salari. Alle nuove generazioni viene proposto, invece, un destino che oscilla tra disoccupazione e precarietà. La ripresa se c’è è flebile, debolissima e, soprattutto, senza occupazione. L’invocazione dei governi, come in un rituale senz’anima, della crescita lascia il posto, nella realtà, a una deflazione dell’economia che segue quella dei salari. La scomparsa del sindacato lascia sgomenti. Senza freni, la macchina prosegue la sua corsa distruggendo socialità e diritti.
I danni sociali sono cosi gravi che si possono ben prevedere gli scoppi di rivolta. Accadono, difatti, ma (solo per ora?) non sufficienti a mettere in discussione il processo in atto, ne le scelte dei governi, i quali li mettono nel conto, mettono nel conto cioè le rivolte sociali come quelle politiche, che, pur di diverso segno, vengono poi, in ogni caso, tutte catalogate come populismi. I sostenitori della governabilità contano che esse non raggiungano mai la massa critica necessaria a mettere in crisi le politiche di austerità e il processo costituente del capitalismo finanziario europeo. Perché il centro della questione sta proprio qui, nella sorte del processo costituente di questo regime neoliberale. Perciò dobbiamo ancora scavare, per poterli aggredire, sui suoi punti di forza, su come la sua avanzata ha modificato nel profondo la società, le sue componenti, su come sta forgiando le sue istituzioni, generando norme di vita, culture, propensioni.
Abbiamo visto, anche nel convegno svolto dalla Fondazione Cercare ancora sulla incompatibilità tra questo capitalismo e la democrazia, come il grande capitale, in tutte le sue componenti finanziarie, produttive, guadagnando la dimensione globale, ne e stato ed e il motore, combinandosi strettamente, piuttosto che farne senza, con le politiche governative degli Stati. La crisi non è diventata cosi per nulla un’opportunità al fine di mettere in discussione le politiche neoliberiste che, invece, con le politiche di austerità, hanno avuto un rafforzamento secco, una radicalizzazione e un radicamento duro. In un recente libro Pierre Dardot e Christian Laval hanno analizzato a fondo il fenomeno lungo una interpretazione assai convincente e che già si intuisce dal titolo del libro "La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista".
In esso non solo appare chiaro ciò che, per esempio, Riccardo Bellofiore sostiene da anni anche su questa rivista, e che, cioè, il neoliberismo, a partire dai suoi stessi maestri Hayek e Friedman, non ha mai pensato di far senza lo Stato, ma si evidenzia bene come si tratti piuttosto, nella sua attuale versione, di una razionalità governamentale ambiziosamente indirizzata a plasmare la condotta delle persone attraverso la produzione di vere e proprie norme di comportamento. Si potrebbe dire altrimenti, che cioè sono gli Stati ad aver affermato, come generale, il modello concorrenziale dell’impresa e del mercato e ad averlo introdotto in tutte le dinamiche sociali. Quando l’individuo viene definito e considerato un capitale umano, cosa viene alla luce se non la tendenza ad assumere pienamente l’uomo dentro i meccanismi del mercato e della concorrenza?
Cosi non viene più cercato soltanto il consenso alle politiche del governo, ma si cerca di plasmare il soggetto individuale fino a configurare la conquista, da parte del capitale, di un nuovo orizzonte antropologico. L’individuo, come d’altra parte lo Stato, passando per i corpi intermedi, tutti risulterebbero allora regolati da un unico sistema pervasivo che non è più solo un modello economico, bensì il governo di tutte le attività umane secondo il principio della concorrenza.
Ma questo terribile meccanismo è messo alla prova a sua volta dalle contraddizioni interne ed esterne da cui l’Europa reale è attraversata, sia per il suo essere immersa in un mercato globale nel quale sono presenti in forza protagonisti conflittuali, sia per le ragioni sociali che al suo interno scavano la crisi e la risposta alla crisi. Non è solo il residuo che sempre, in ogni caso, resta fuori da ogni meccanismo di integrazione subalterna, qui è in gioco il potenziale di ribellione e di rottura sociale che le mille forme di collera e di resistenza indicano già ora esistente, quand’anche in larga misura sommerso. Del resto, abbiamo visto come la demolizione della democrazia in Europa e la costituzione, al suo posto, di un’Europa oligarchica, rispondano all’esigenza della classe dirigente di governare una politica economica e sociale altrimenti impossibilitata a guadagnarsi un consenso di massa.
L’incompatibilità di fondo tra il capitalismo finanziario e la democrazia in Europa ha nelle politiche di austerità e neoliberiste il campo concreto della sua conferma. Nella crisi la nuova borghesia internazionale ed europea ha alzato l’asticella della sfida, è passata dalla pars destruens delle conquiste sociali storiche da parte del primo neoliberismo alla pars construens di un nuovo modello sociale neomercatilista a vocazione totalizzante nel quale è celato il nocciolo duro di classe, cioè il ritorno dei rapporti sociali all’Ottocento, quell’Ottocento che ha preceduto la nascita del movimento operaio: appunto il gran ritorno. Questo processo confida, come ben sappiamo, sull’eclissi nella scena politica della rappresentanza del suo storico avversario, il movimento operaio e le sue organizzazioni. Ma confida anche (e dovremmo capire meglio cosa sta cambiando nella soggettività e nelle culture di massa) nell’oscuramento, nella realtà sociale e nelle culture diffuse, della lettura della società in termini di classe. In Italia il nesso tra questo mutamento nelle culture diffuse e la mutazione genetica delle organizzazioni politiche della sinistra è stato assai stringente.
Basterebbe, per rendersene conto, pensare soltanto a più recenti episodi che hanno riguardato le relazioni sociali. Si discute di dar luogo in Italia al contratto unico con il quale si introduce, in realtà, il diritto al licenziamento per un lunghissimo periodo lavorativo, spezzando nel fondo l’unitarietà della compagine lavorativa e cancellando la barriera dell’articolo 18, eretta contro l’arbitrio padronale. A guardare le reazioni della politica, della sinistra e del sindacato confederale tutto ciò sembra incredibilmente naturale.
Sulla rappresentanza sindacale, i sindacati confederali firmano, senza fiatare e senza consultare i lavoratori, un testo unico sulla rappresentanza che contiene ciò che la Cgil ha sempre rifiutato in tutto il secondo dopoguerra, cioè di mettere la mordacchia al conflitto di lavoro sottoponendolo all’arbitrato delle parti congiunte. Un’enormità che rovina contro l’idea fondativa dell’autonomia dei lavoratori secondo la quale l’impresa è attraversata da un conflitto tra i due interessi in contrasto tra di loro. Vale per l’interpretazione di qualsiasi fatto dell’economia. La Fiat compra la Chrysler ed è tutto un inno all’Italia e alla Fiat. Quando la Fiat era la Fabbrica Italiana Automobili Torino, cioè una grande impresa che da Torino investiva della sua attività produttiva l’Italia e l’estero, la sinistra era capace di rifiutare le pretese dell’azienda di far credere che ciò che fosse stato buono per la Fiat lo sarebbe stato per l’Italia. Eppure vi erano occupati più di centomila lavoratori, senza contare l’indotto dell’auto. Oggi che la Fabbrica Italiana Automobili Torino non c’è più, che i suoi occupati sono ridotti a un pugno, che la Fiat, in Italia, è diventata sostanzialmente una finanziaria, la sua acquisizione della Chrysler, con il definitivo cambiamento del baricentro geografico del suo interesse a scapito del Paese e della sua occupazione, viene comunemente scambiato per un successo.
La demolizione dall’alto di ogni cultura critica, in specie di quella di classe, combinandosi con la diffusione di modelli individualistici e, sul nostro versante, quello delle popolazioni, ciò che consente al processo costituente del capitalismo finanziario in Europa di puntare a realizzare un regime compiuto, cioè, appunto, di oltrepassare la dimensione economica, strutturale, che pure resta centrale, per dispiegarsi in operazione egemonica e di dominio (i due termini non sono più in alternativa) sull’intera società e sulla vita delle persone: il regime. Come, dove e quando esso si possa operare è l’interrogativo capitale delle culture politiche critiche. Un interrogativo assai difficile.
Si sostiene che c’è un limite oltre il quale la divaricazione tra l’accumulazione di una ricchezza esorbitante nelle mani di pochi e la povertà dilagante, in altre parole che ci sarebbe una soglia critica della diseguaglianza oltre la quale si spezzerebbe l’organizzazione del consenso e, in questo caso, entrerebbe in crisi la neutralizzazione del dissenso operato dal regime. Ma noi sappiamo che non esiste alcuna relazione meccanica tra l’aggravamento del disagio sociale e la crisi del sistema politico e cosi la questione torna alla soggettività, alla massa critica del dissenso e del conflitto sociale, all’efficacia dei movimenti.
Fonte: Alternative per il Socialismo




Recent comments
2 anni 18 weeks ago
3 anni 19 weeks ago
3 anni 19 weeks ago
3 anni 21 weeks ago
3 anni 21 weeks ago
3 anni 22 weeks ago
3 anni 22 weeks ago
3 anni 23 weeks ago
3 anni 24 weeks ago
3 anni 24 weeks ago