Perchè abbiamo amato Pasolini (di fausto Bertinotti)

Non si salverà neppure Pier Paolo Pasolini dalla celebrazione. La celebrazione mediatica è un segno dei tempi. La secolarizzazione, di cui Pasolini aveva letto in anticipo, seppure credo unilateralmente la barbarie, ha invaso e pervaso di sé almeno il grande campo delle comunicazioni. Anniversari di morte e di nascita, come la scomparsa di una personalità pubblica, diventano l’occasione di un trionfo mediatico. Un tempo si diceva che il comunista buono era il comunista morto, ora vale per tutte le persone che hanno raggiunto il nuovo codice d’onore, cioè la notorietà.
Non so se potrà bucare il muro della prevedibile retorica dar conto, al contrario, di come una generazione politica di sinistra, interna al Movimento operaio, giovani comunisti, socialisti, abbiano amato Pasolini e abbiano continuato a farlo, malgrado alcune sue scelte politiche risultassero per loro urticanti e li vedesse su opposte frontiere. Era il ’68 quando, nella battaglia di Valle Giulia a Roma, che aveva opposto gli studenti alla polizia, Pasolini scrisse ne “Il Pci ai giovani”: «Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti, perché i poliziotti sono figli di poveri». Il colpo fu duro. Pensammo, e continuo a pensare, che si sbagliava, trascinato nell’errore da un poco significativo dato sociologico e dal comprensibile odio per tutte le borghesie. Sbagliava tanto da non vedere la risposta operaia e studentesca che stava attraversando il mondo intero e che avrebbe aperto le porte alla straordinaria stagione di lotta di classe che ha trasformato il nostro Paese negli anni Settanta, anche rendendolo un po’ più umano, proprio a partire da quel biennio rosso ’68-’69.
Una ballata da dentro quel nuovo mondo, proprio dentro quello scontro, ne dava conto in presa diretta, con le speranze e i sogni che stavano nascendo, seppure lontani dalla terra arata e seminata dal sempre grande intellettuale. Era la ballata Valle Giulia di Paolo Pietrangeli. La rottura continua a scavare nel fondo, fino a rivelarsi in modo illuminante nel famosissimo testo La scomparsa delle lucciole. La tesi di Pasolini va al fondo di una mutazione antropologica che viene fatta risalire alla metà degli anni Sessanta, comparabile all’inquinamento dell’aria e dell’acqua, che produce la scomparsa delle lucciole e comparabile all’invasione nelle borgate delle “brutte costruzioni” che la snaturano. L’industrializzazione e la società dei consumi avrebbero demolito quel che Pasolini definiva “il grande Paese”, il mondo del Pci che si stava formando dentro il Paese Italia. Secondo Pasolini, quel popolo, che avendolo tanto amato aveva ben conosciuto, subiva una mutazione che lo ha deformato come la sua stessa coscienza, rendendolo «degenerato, ridicolo, mostruoso, criminale».
Alla luce di questa inquietante traiettoria, Pasolini rivedrà drammaticamente, fino al rovesciamento, anche il suo giudizio, sui protagonisti dei suoi romanzi: i ragazzi della borgata romana. Dopo la scomparsa delle lucciole, anche la politica avrebbe cambiato di segno, rendendo inusabile persino il discorso del Politecnico e di Fortini sulla presenza in Italia di due fascismi: soggettivo e oggettivo. Dopo, la Democrazia cristiana diventa il vuoto, e i suoi dirigenti le “teste di legno”. Si sarebbe preparato così il passaggio dal vecchio assetto di potere a quello nuovo della polizia tecnocratica e sovranazionale. Non tragga in inganno la singolare aderenza di questa conclusione, quella della scomparsa delle lucciole, con la situazione attuale. Di mezzo, ci sono tutti gli anni Settanta, ci sono i suoi protagonisti: gli operai dei Consigli, i giovani, le donne. In mezzo c’è stata una contesa che ha cambiato il Paese con riforme sociali e di civiltà e soprattutto con una partecipazione e un protagonismo delle masse che avrebbe potuto portare a un’altra società, a un altro modello di società. È la sconfitta di quella storia che ci ha condotti qui, non la sua esistenza, che invece il poeta si è negata.
La distanza politica non poteva essere più grande, e proprio in quella fase, la metà degli anni Settanta, si faceva una distanza cruciale. Eppure, un filo forse allora poco visibile quanto resistentissimo ci ha continuato a legare a lui. Bisognerebbe riuscire a spiegarlo. Non so se in casi come questi, l’incontro tra dei giovani critici e uno scrittore, si possa parlare di innamoramento. Noi lo conoscemmo divorando i suoi Ragazzi di vita e Una vita violenta. Non eravamo così raffinati da aver saputo guardare bene dentro le straordinarie poesie che li avevano preceduti. Quei libri, per noi, furono una rivelazione. Ci portarono dentro le borgate romane fino al Prenestino a conoscere il sottoproletariato, così lontano dalla realtà operaia e politica che frequentavamo, e vicini alla sua scandalosa umanità. In quell’universo, il Riccetto, un ragazzo che vive di espedienti, di furti e di altro “fuori norma”, si tuffa nell’acqua del Tevere e rischia la sua vita per salvare una rondine che stava affogando. La vitalità, la spontanea generosità del ragazzo di borgata sono una risorsa di umanità, ma non possono essere un dono permanente. Quando Riccetto perde i suoi riccioli e si integra perde quella dote e si avvia al drammatico destino costruitogli da una società ingiusta e inumana.
Ma lì, in quel mondo, vivevano le lucciole, che sono la ragione della poetica di Pasolini. Lo dirà lui stesso nelle Ceneri di Gramsci. Il poeta si rivolge a Gramsci dicendogli «sono attratto da una vita proletaria a te anteriore, è per me una religione. Per la sua allegria (lo attrae), non la millenaria sua lotta, la sua natura, non la sua coscienza». C’è in una frase tutta una ragione di attrazione profonda e di un dissenso. Ritorna allora l’interrogativo: “Allora perché Pasolini?”. Già negli anni Sessanta, non è facile capire bene perché quei giovani militanti che si volevano eredi di marxismi eretici, che leggevano la politica del sindacato e delle sinistre alla luce della centralità del conflitto di classe, nella lente della lotta operaia, fossero così attratti dalla tematica pasoliniana e dalle sue opere, e ancora di più dalla sua figura di intellettuale, di scrittore, di artista. Lo inseguimmo ovunque: nel romanzo, nella poesia, nella saggistica, nella linguistica, fin dentro quel suo cinema così intenso e illuminato, che il capolavoro La ricotta aveva preannunciato.
Ci avevano avviati a lui i Dialoghi con Pasolini, la rubrica che lo scrittore teneva su Vie Nuove, un periodico comunista e popolare tra gli ultimi anni Cinquanta e i primi Sessanta. Erano state quelle risposte alle lettere dei lettori, che saranno poi raccolte nel volume Le belle bandiere. Ancora oggi, esse ci parlano della temperie di un tempo, di ricerca e di impegno. Pasolini vi era immerso da protagonista, secondo la sua interpretazione, e una presenza profetica in un tempo che era di transizione, cercando le risposte anche a quella che veniva definita una crisi (una delle tante crisi) del marxismo. Ma non nelle prossimità politiche vanno cercate quelle passioni nostre che si rivelarono durevoli. Infatti, anche quando quelle prossimità vennero meno, le nostre passioni continuarono. Già allora il panorama intellettuale e letterario avrebbe suggerito di poter alimentare, quelle stesse passioni, con altre presenze, suscettibili di maggiori sintonie politico-culturali. Scrittori come Franco Fortini, poeti come Edoardo Sanguineti, il Volponi del Memoriale, per altri versi ancora Calvino, e poi per intero il “Gruppo 63” che animava la ricerca della nuova Avanguardia, e altri ancora avrebbero potuto esserlo allo stesso titolo.
Perché quella connessione sentimentale con Pasolini? Una ragione forse si trova nel doppio di quella sua frase che abbiamo citato. Da un lato, un assoluto religioso della ricerca di un popolo che vive già, come può, l’umanità cercata per il futuro, l’avversione radicale alla società dei consumi, al capitalismo delle società violente come rifiuto sistematico del mondo borghese, conducono alla tensione profetica del poeta. Isaac Deutscher titola uno dei tre volumi della trilogia su Leone Trotskj Il profeta disarmato. Nessuna parentela con Pasolini, se non forse proprio la definizione di “profeta disarmato”. Noi quell’essere disarmato lo trovavamo nel secondo paragrafo della frase citata, quella in cui si diceva che non l’attraeva di quel popolo, che pure cercava, la sua lotta, la sua coscienza, cioè si può dire la classe operaia. Non si può prendere la scorciatoia per spiegare il rapporto con Pasolini con la sua grandezza, perché anche altri ce ne sono.
Forse ci aiuta invece a capirlo proprio questa drammatica tensione tra i due poli che, uniti, hanno riempito la politica del Novecento. Deprivato di quell’unione tra popolo e classe, Pasolini non si è arreso e ha continuato a cercare e a testimoniare. Conservatore e rivoluzionario, com’ebbe a dire Berlinguer del comunista. Alla modernità Pasolini si è messo di traverso, come Walter Benjamin, credo pensasse che la rivoluzione si fa premendo il freno e non l’acceleratore. Forse era proprio questo non poter essere mai pacificato che non consentì mai al dissenso di farsi separazione. “Loro” uccisero il profeta. Non so se avesse ragione Gianni Borgna nella sua ricerca sulla genesi dell’uccisione del poeta, uccisione che definiva politica. Certo, fu un omicidio culturale. Pasolini portava con sé nel mondo il carisma dell’ultimo grande intellettuale civile del Paese.
Nella contesa tra Sartre e Camus non si trattava allora di scegliere da che parte stare, ma di connetterli, di connettere l’intellectuel engagé e l’uomo in rivolta. Uno scrittore suo coetaneo, seppure da lui lontanissimo, Beppe Fenoglio, aveva trovato la parola giusta che credo possa definire il nostro Pasolini. Ritrovando le speranze del nuovo mondo che si affacciava, le speranze dell’aurora, Fenoglio scriveva che nasceva allora «quella nuova parola, nuova nell’acquisizione italiana, così tenera e splendida, nell’aria dorata: partigiano». Partigiano. Forse sta qui la ragione di una passione durevole.
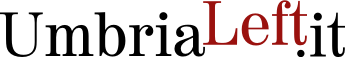



Recent comments
6 anni 13 weeks ago
6 anni 14 weeks ago
6 anni 14 weeks ago
6 anni 14 weeks ago
6 anni 14 weeks ago
6 anni 15 weeks ago
6 anni 15 weeks ago
6 anni 16 weeks ago
6 anni 16 weeks ago
6 anni 16 weeks ago