SI PUÒ CHIAMARE ANCORA GIORNALISMO?

di Marina Nardi
Se si chiudono gli occhi per qualche giorno, magari per necessità, riaprendoli si fa caso con raccapriccio a una cosa: il giornalismo italiano ormai pratica un solo genere: la polemica. Si può chiamare ancora giornalismo? La titolazione, gli editoriali, le inchieste, gli elzeviri, le cosidette pagine culturali, le pagine sportive tutto tranne la cronaca nera (ma non sempre) è sottomesso alla logica della polemica. Ogni testo deve contenere esplicitamente o implicitamente, violentemente enunciato o furbescamente sottilmente sussurrato, un argomento utile alla polemica quotidiana. Tutto è soggiogato alla ragione polemica. Ora, la polemica non è un genere come un altro, la parola viene da polemos, significa guerra. E’ guerra fatta con strumenti appena diversi dalle armi da fuoco, non meno violenti perché le parole spaccano la roccia, e le leggi che la regolano sono le stesse. E’ il criterio balistico che domina il campo. La logica militare. Ogni gesto, ogni scritto, ogni atto, ogni testo non si pone altro obiettivo che quello dell’efficacia bellica, la capacità di colpire l’altro, il nemico: è il volume di fuoco che conta, la capacità di danneggiare l’altro, la tornitura della mazza ferrata, tutto il resto è ornamento. Non si tratta di convincere ma di vincere. Non si tratta di controversia, i giornali e i libri giornalistici sono organi di guerra intenti a tenere alto il morale della truppa e offrirle quotidianamente munizioni. La polemica è la metastasi del confronto dialettico. Deve galvanizzare il seguace, farlo sentire forte, ben armato, vincente, alimentando collera disprezzo e animosità. Si può chiamare ancora giornalismo? E’ l’opposto della conoscenza (del mondo), perché quella si fa andando per il sottile, allineando i necessari distinguo, esitando, rischiarando le ambiguità inevitabili di ogni Valore, le sfumature che a volte li confondono, i confini sempre nascosti tra torto e ragione, gli slittamenti clandestini del senso, gli equivoci segreti e le cattive mescolanze che sono difficilmente isolabili con l’analisi, perché sono opera degli stati profondi e nauseabondi dell’inconscio collettivo. La conoscenza si fa nutrendo l’arte della contraddizione e della perplessità, dello scrupolo, dell’ascolto e della compassione, la cui assenza si chiama tracotanza. Ma questo non permette di confezionare oggetti contundenti. La polemica non sa che farsene della conoscenza perché è la potenza offensiva che le dà valore, e tutto è lecito per questo, esattamente come sui teatri di guerra. Per funzionare occorre che tutto sia massimamente semplificato e contratto in frasi ledenti. E una volta entrato nel cerchio della pratica bellica non si sfugge. Perché Polemos è più forte di chi ne fa uso. La Forza (ci mostra l’Iliade, e lo porta a chiarezza Simone Weil) è sempre più potente di chi la esercita. Non è una entità che si lascia usare, è lei che si impone su chi la usa, sottomettendolo alle sue ferree leggi, basate sulla negazione ferina di ciò che ci rende umani. E il mercato a sua volta di questo si pasce. Le opinioni sono una merce come un’altra, sono denaro contante per chi scrive e chi pubblica, lo scontro feroce è intrattenimento, per vendere di più, per avere più spettatori devi animare (più o meno scopertamente) l’arena sanguinaria. La militarizzazione della lingua, che significa militarizzazione della vita quotidiana, procura grandi proventi.
Pare che esista una legge dell’evoluzione culturale, secondo la quale le idee ultra semplificate finiscono sempre con lo spodestare quelle elaborate, e ciò che è bellicoso volgare e spregevole finisce sempre con lo spodestare la bellezza. Ciò nonostante la bellezza perdura (Gregory Bateson - Mente e natura)."
Fonte: Facebook
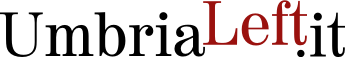



Recent comments
6 anni 13 weeks ago
6 anni 13 weeks ago
6 anni 14 weeks ago
6 anni 14 weeks ago
6 anni 14 weeks ago
6 anni 14 weeks ago
6 anni 15 weeks ago
6 anni 15 weeks ago
6 anni 15 weeks ago
6 anni 15 weeks ago