Il futuro del movimento di liberazione palestinese - di Franco Ferrari

L’invasione di terra israeliana della striscia di Gaza si è spostata verso la zona sud del territorio. La resistenza delle milizie di Hamas e di altri gruppi armati palestinesi di minor peso determina un lento stillicidio di morti tra le truppe dell’esercito di occupazione. Intanto Israele continua a bombardare in modo indiscriminato i quartieri di Khan Younis, Rafah e altre zone densamente abitate. In molti di queste si sono riversati i profughi del nord a seguito delle intimazioni rivolte dallo stesso esercito d’invasione. Il numero delle vittime continua a crescere e le condizioni di vita dei civili si fanno sempre più precarie, mentre si fa più concreto lo spettro della fame.
Tutto lascia prevedere che l’invasione militare dell’esercito di Tel Aviv continuerà ancora per diverse settimane per poi trasformarsi in una qualche forma di occupazione, i cui contorni non sono ancora chiari agli osservatori e forse nemmeno del tutto evidenti per Netanyahu e il suo governo di fanatici estremisti.
Israele ha proclamato l’obbiettivo di eliminare Hamas da Gaza, un risultato tutt’altro che semplice da ottenere, sia per il radicamento dell’organizzazione di resistenza islamica, sia per il rifiuto israeliano di concepire qualsiasi altra soluzione di governo della striscia, compresa quella ipotizzata dagli Stati Uniti di rimettere in campo l’Autorità Nazionale Palestinese di Abu Mazen.
L’azione militare di Hamas del 7 ottobre, che ha duramente colpito Israele, e la guerra messa in atto da quest’ultima contro Gaza sono considerati eventi tali da cambiare per sempre lo scenario del conflitto israelo-palestinese. In realtà, se si considerano i due elementi fondamentali che stanno alla base di questo conflitto, essi non sembrano destinati a modificarsi. Innanzitutto vi è il diritto del tutto legittimo dei palestinesi ad un proprio stato pienamente sovrano, riconosciuto dai principi della giustizia naturale ma anche dalle deliberazioni dell’Onu, fin dal 1948. Poi vi è il fatto, conclamato ed evidente, che Israele non intende riconoscere questo diritto e continuerà a fare di tutto per impedirne la realizzazione.
Anche Biden ha dovuto riconoscere che il governo israeliano e Netanyahu in primo luogo non hanno nessuna intenzione di mettere fine all’occupazione dei territori conquistati militarmente nel 1967, benché questo non impedisca agli Stati Uniti di continuare a fornire generosamente le armi grazie alle quali questa occupazione può perpetuarsi nel tempo.
Per Tel Aviv non sono interlocutori possibili né Hamas, né l’Autorità Nazionale Palestinese, benché quest’ultima abbia da sempre accettato tutte le richieste preliminari avanzate da Israele e Stati Uniti per poter avviare un percorso di pace. L’ANP ha rinunciato ad ogni forma di violenza e partecipa attivamente alla repressione della resistenza all’interno dei centri urbani su cui mantiene un certo controllo. Il risultato della strategia trattativista e subalterna di Abu Mazen ha condotto alla totale impotenza nei confronti dello stato occupante. Israele ha potuto continuare, senza alcuna limitazione, ad estendere gli insediamenti dei coloni e a impedire ai palestinesi di poter condurre una vita decente sulla loro terra, senza subire continue e odiose forme di vessazione. Alle quali si aggiungono le uccisioni e gli arresti indiscriminati che proseguono ininterrottamente da anni e che si sono intensificati dopo il 7 ottobre.
L’ANP non sembra avere alcuna strategia per modificare uno statu quo che, con l’estendersi degli accordi tra Israele e alcuni paesi arabi, sembrava destinato a cancellare per sempre dall’agenda politica internazionale la questione palestinese. Nemmeno ora sembra profilarsi una qualche idea tale da ridare corpo ad una struttura tanto pesante nel numero che deve mantenere (forze di polizia e burocrazia) quanto insignificante nella capacità di produrre risultati utili a chi vive nella West Bank sotto il tallone dell’esercito di occupazione.
L’operazione di Hamas, certamente molto arrischiata e discutibile nella sua realizzazione, aveva come obbiettivo primario di interrompere una situazione che si stava rivelando priva di prospettive. Per la stessa Gaza non si profilava nient’altro che una stentata sopravvivenza all’interno di un territorio sempre più sovrappopolato e in grado di resistere solo grazie agli aiuti internazionali.
La dirigenza di Hamas, che ha registrato secondo diversi analisti un mutamento degli equilibri tra le varie componenti (più forte Gaza rispetto alla diaspora e decisiva la componente militare rispetto a quella civile), ha ritenuto indispensabile realizzare una iniziativa militare clamorosa tale da sparigliare tutto il quadro. Probabilmente ha avuto un impatto superiore a quello atteso dalla stessa leadership delle Brigate al Qassam, anche per il convergere di eventi casuali come lo svolgimento del rave party nel deserto, i cui partecipanti hanno tragicamente contribuito a far innalzare il numero delle vittime civili.
Secondo la classica logica israeliana, per la quale ogni risposta a qualsiasi tipo di attacco deve essere enormemente spropositata e colpire anche i civili, ci si poteva aspettare una reazione estremamente brutale, anche se forse non nelle dimensioni con la quale si sta realizzando. Ma occorre tener presente che la società israeliana (come denunciano intellettuali coraggiosi ma relativamente isolati come Gideon Levy, Shlomo Sand, Ilan Pappé) ha introiettato profondamente una concezione razzista nei confronti dei palestinesi e un senso di assoluta impunità nell’uso della violenza contro di essi.
L’operazione militare di Hamas del 7 ottobre ha certamente fatto saltare lo stato quo, interrotto almeno per ora l’intesa tra Israele e l’Arabia Saudita, cardine del processo di normalizzazione del Medio Oriente in chiave antipalestinese, e in qualche modo riportato il tema Palestina al centro dell’attenzione mondiale. Molto meno chiaro è quale sia il progetto strategico sul quale scommette il Movimento di resistenza islamico. Dal punto di vista militare potrebbe sperare di portare l’esercito di Tel Aviv ad insabbiarsi per lungo tempo nell’occupazione di Gaza.
Non bisogna sottovalutare il fatto che per l’invasione Netanyahu ha dovuto mobilitare un gran numero di riservisti, cittadini che normalmente vivono una vita normale, per integrare i militari di professione. Il loro impegno ha un forte impatto sull’economia e sulle condizioni di vita delle rispettive famiglie, senza contare il rischio di essere uccisi dalla guerriglia della resistenza palestinese. A lungo andare questa situazione potrebbe rivelarsi difficilmente sostenibile per Israele e nel momento in cui dovesse ridurre la sua presenza militare a Gaza, la striscia potrebbe tornare facilmente sotto il controllo di Hamas.
Se questo può essere il calcolo strategico del movimento, più difficili da definire sono gli obbiettivi politici. Hamas da diversi anni ha riconosciuto di fatto l’ipotesi di costituzione di uno stato palestinese nei territori occupati da Israele nel 1967. Lo ha fatto però senza rinunciare retoricamente all’obbiettivo della liberazione dell’intera Palestina e non chiarendo nemmeno quale dovrebbe essere il futuro della popolazione ebraica che ormai corrisponde all’incirca a quella araba.
Questo aspetto divide Hamas dall’ANP, così come li separa la strategia per raggiungere l’obbiettivo dello stato palestinese a fianco di quello israeliano. Mentre l’Autorità si è affidata ad una trattativa che non esiste più da anni, per Hamas senza ricorso a forme di resistenza anche armata, Israele non accetterà mai di lasciare i territori.
In altre parole, solo se Israele paga un prezzo per l’occupazione potrà accettare di mettervi termine. Se questo sembra un dato indiscutibile, resta da dimostrare che la strada intrapresa da Hamas, oltre al costo enorme che fa pagare ai civili palestinesi, possa ottenere risultati migliori di quelli raggiunti con il processo di Oslo che oggi tutti ritengono fallito.
Per il movimento di liberazione nazionale palestinese ci sono alcune condizioni che possono consentire, anche se in tempi certamente non brevi, di fare dei passi avanti sul percorso accidentato della conquista della sovranità.
La prima è quella della ricomposizione unitaria del movimento. Arafat ci era riuscito attraverso l’OLP che consentiva anche un relativo pluralismo. Allora il ruolo di Fatah era largamente predominante e questo creava un assetto relativamente stabile, mentre oggi il campo palestinese è diviso tra Fatah ed Hamas e tutti gli sforzi messi in atto dal 2006, quando si tennero le elezioni nei territori, per trovare una riconciliazione tra le due organizzazioni sono sempre falliti.
La seconda condizione è che si definisca con chiarezza e senza artifici retorici l’obbiettivo politico che il movimento persegue. Restare eternamente in bilico tra l’obbiettivo dei due stati e ipotesi alternative sempre piuttosto vaghe e indeterminate, oltre che non legittimate sul piano internazionale, indebolisce la credibilità del movimento.
Il terzo elemento è la definizione di una strategia condivisa per raggiungere un obbiettivo chiaramente definito. La sola strada della trattativa è finita in un vicolo cieco, il ricorso a forme di resistenza violenta (condiviso anche da gruppi presenti nella West Bank che non fanno capo né ad Hamas né a Fatah), tenendo conto dei rapporti di forza estremamente sfavorevoli alla resistenza palestinese sul piano militare dovrebbe basarsi su una partecipazione ed una adesione di massa. Ogni forma di deviazione militarista o terroristica indebolisce la possibilità di rafforzare la solidarietà globale ai palestinesi ma anche di differenziare e disarticolare la società israeliana.
Una qualche precisazione di questi aspetti sembra indispensabile per fare passi avanti sulla strada della fine dell’occupazione e della istituzione di uno stato palestinese.
Fonte: transform-italia.it
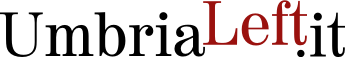



Recent comments
6 anni 11 weeks ago
6 anni 11 weeks ago
6 anni 12 weeks ago
6 anni 12 weeks ago
6 anni 12 weeks ago
6 anni 13 weeks ago
6 anni 13 weeks ago
6 anni 13 weeks ago
6 anni 13 weeks ago
6 anni 13 weeks ago