Il limite invalicabile - Giulio Calella, Francesca Coin

La prima volta che abbiamo sentito il termine Great Resignation è stato nel 2021 negli Stati uniti, dove si era registrato un aumento delle dimissioni individuali di circa il 20% rispetto al 2019, arrivando a 48 milioni di persone che si sono dimesse dal proprio lavoro in un anno. Inizialmente si è pensato a un semplice rimbalzo post pandemico dopo il congelamento del lockdown – ossia a un recupero delle mancate dimissioni del 2020 – ma le dimissioni sono cresciute ancora nel 2022, arrivando negli Usa a 50 milioni di persone. Questa crescita si è subito rivelata non solo un fenomeno del mercato del lavoro statunitense: dati simili si sono visti anche in Cina e naturalmente in Italia, con un aumento delle dimissioni del 30% rispetto al periodo pre-pandemia con 2 milioni di persone dimesse nel 2022.
Francesca Coin nel suo libro Le grandi dimissioni (Einaudi, 2023) ha indagato a fondo questo fenomeno per capirne origini, composizione e possibili conseguenze sociali e politiche, intervistando centinaia di persone che si sono dimesse in Italia negli ultimi due anni. Ne è uscita fuori una vera e propria inchiesta sul mondo del lavoro di oggi, con le dimissioni come angolo di visuale per indagare le condizioni materiali e di vita della working class contemporanea.
Non capita spesso che un saggio sul lavoro susciti la discussione che sta creando il tuo libro: decine di presentazioni in giro per l’Italia con numeri di partecipazione davvero rari se non per romanzi di autori di best seller. L’interesse suscitato conferma che hai affrontato una frustrazione diffusa che suscita interrogativi diversi tra loro. Ci racconti qual è il bisogno di approfondimento e condivisione che stai incontrando nelle presentazioni del tuo libro?
C’è stata effettivamente molta partecipazione nelle discussioni pubbliche. In alcuni casi si è trattato di una partecipazione insieme esistenziale, intima e politica, come se ci fosse un bisogno viscerale di tornare a parlare di lavoro e del suo senso, nella nostra società. L’idea che mi sono fatta è che, da troppo tempo, di lavoro non si parla nei luoghi preposti. Se ne parla fuori dai luoghi di lavoro, nei bar, nei supermercati, tra amici o con medici e terapeuti. Oppure discutendo di salario ma non anche dei ricatti o delle vessazioni che si palesano nei luoghi di lavoro. Questo accade perché, in molti casi, nelle microimprese italiane ciascuno ha un rapporto diretto e individualizzato con la direzione. Pertanto, da tanti anni in alcuni contesti lavorativi polverizzati molte persone «risolvono» i propri problemi di lavoro direttamente con il datore di lavoro, senza parlarne con nessuno. In questi casi di lavoro non si parla «dentro», se ne parla «fuori», anche perché dentro ai luoghi di lavoro spesso non c’è libertà di parola.
Nei dibattiti esce quello che ti aspettavi o qualcosa di ancora diverso che ti colpisce?
Nei dibattiti esce moltissimo il vissuto lavorativo di chi è presente. Si parla di ristorazione, di grande distribuzione, di lavoro culturale, di cottimo, di sfruttamento, di ricatti morali ed economici, di colpa, di rabbia e di strategie. Si parla anche tanto di tempo, di tempo che manca, di tempo per vivere e del bisogno di vivere. «Vivere è avere tempo», diceva Pascal Chabod. Tuttavia, molte persone di tempo non ne hanno più.
Quello delle dimissioni è un tema contraddittorio, specie per chi affronta la questione del lavoro a livello sindacale. Qualcuno sottolinea che le dimissioni sono una pratica individuale di per sé indifferente alla necessità di generare conflitto di classe collettivo. Tu sostieni che le dimissioni non siano la soluzione ma il sintomo di un «doppio fallimento», da un lato delle modalità organizzative del lavoro contemporaneo e dall’altro anche delle organizzazioni sindacali. Ci spieghi meglio cosa intendi?
Ho usato il termine «doppio fallimento» per dire che, da un lato, la fuga dal lavoro è il sintomo del fallimento dell’organizzazione di chi lavora. Lo suggeriva già Albert Hirschman: laddove non c’è voice, la possibilità di dare voce alle proprie rimostranze, c’è exit, un’uscita dai luoghi di lavoro. E tuttavia contemporaneamente le fughe dal lavoro sono il sintomo del fallimento dei tentativi aziendali di disciplinare il lavoro perché in molti casi chi non vuole essere sfruttato, in assenza di forme di resistenza collettiva, se ne va. In questo senso, le fughe dal lavoro andrebbero sempre viste come sintomi di un contesto di malessere, in cui vive un desiderio profondo di cambiare il mondo del lavoro ma sembra che non vi sia possibilità di farlo. Per questo, la crescita del tasso di dimissioni volontarie chiama in causa il sindacato: perché sono il sintomo di un malessere che cerca una soluzione che può essere risolutiva solo se diventa collettiva.
Che tipo di risposta c’è stata di fronte alla tua ricerca da parte di chi fa organizzazione sindacale?
Tanti delegati e delegate mi hanno aiutata a scrivere questo testo. Quindi da un lato c’è stata una grande partecipazione da parte di sindacalisti del commercio, del terziario o, in generale, dei servizi. Poi c’è chi invece non ha voglia di ascoltare. Una volta ho fatto una presentazione con una persona con un ruolo di responsabilità all’interno di un sindacato ed è venuta a discutere il libro senza averlo letto: non aveva voglia di ascoltare, ha infilato nella presentazione una serie di considerazioni a caso con quella sicurezza di chi può dire qualunque cosa perché viene da decenni di vittorie. Peccato che questi decenni di vittorie non ci siano stati. Mi è parsa un’occasione persa.
Quali sono le principali critiche che hai ricevuto?
Ho saputo di alcune persone arrabbiate con me anche se non avevano letto il libro. Una specie di «effetto Sangiuliano», il ministro della cultura che ha partecipato alla votazione del Premio Strega nonostante si fosse fermato alla lettura della copertina. Per alcuni versi penso che il titolo abbia tratto in inganno. Come hai accennato prima, il libro non celebra le fughe dal lavoro come una soluzione, cerca di capire di cosa sono il sintomo. Questo, però, lo si scopre leggendo.
Ci sono settori e tipologie di lavoro in cui le dimissioni sono cresciute particolarmente?
Mi sono concentrata sui settori a saldo negativo, che nel corso del 2021 hanno perso più personale di quanto siano stati in grado di attrarne. Ho usato questo approccio perché le cause delle fughe dal lavoro, in ultima analisi, spesso dipendono da una cattiva organizzazione del lavoro. I settori più colpiti dalle dimissioni, in questo senso, sono quelli del lavoro povero, in cui la retribuzione è più bassa e le tutele ridotte. Io ho indagato in particolare il settore della ristorazione e la grande distribuzione, oltre a quello sanitario e al lavoro femminile, che è interessante non tanto dal punto di vista quantitativo ma qualitativo, per mostrare la disaffezione a un certo ruolo di genere attribuito alle donne. Ma avrei potuto estendere lo sguardo al lavoro dei servizi, bancari e assicurativi, alle società di consulenza, al lavoro sociale, in crisi come quello sanitario, al lavoro culturale, al giornalismo o alla logistica, per fare solo alcuni esempi.
In un mercato del lavoro con i livelli di disoccupazione che ci sono in Italia, si potrebbe pensare che le dimissioni riguardino esclusivamente le professionalità in grado di ricollocarsi più facilmente. Tu invece mostri il contrario: la scelta delle dimissioni è prevalente nei settori del lavoro povero. Quali sono i principali motivi per cui le persone si dimettono e con quali aspettative lo fanno?
Il punto è proprio questo. Il lavoro in Italia si è impoverito e salari così bassi non offrono più una contropartita sufficiente per i sacrifici di chi lavora. Durante una delle discussioni pubbliche mi è divenuto chiaro che c’è una ragione per cui si continua a ripetere che si dimettono solo le professionalità medio-alte: perché equivale a dire che nella struttura produttiva italiana non c’è alcun problema. Non siamo senza una politica industriale da quarant’anni, non c’è un problema di investimento in ricerca e sviluppo né è problematico che da decenni si consideri il lavoro sottopagato una soluzione ai problemi di competitività italiana all’estero o all’interno di settori specifici. Se io dico che si dimettono le professionalità medio-alte, dico che in Italia va tutto benissimo e il mercato è dinamico. E invece in Italia le professionalità medio-alte espatriano perché il mercato italiano non ne ha bisogno. In Italia la qualità del lavoro è bassa, i contratti sono precari e il lavoro è sottopagato. Per lungo tempo questo è stato un problema solo per chi lavorava, perché giustamente in assenza di forme di welfare universale tutti hanno bisogno di lavorare, e lavorare per poco era considerato «meglio di niente». Ora i salari sono scesi così tanto, e il costo della vita è aumentato così tanto, che in alcuni casi non ne vale più la pena.E questo è diventato un problema anche per le aziende.
Nel libro a un certo punto citi una frase di Flavio Briatore: «Non ho mai visto un povero creare posti di lavoro, ma invece di ringraziare rompono anche il cazzo». Considero Briatore spesso istruttivo per la sua capacità di esporre senza filtri la visione del mondo padronale. In questo caso fotografa l’idea veicolata negli ultimi trent’anni, secondo cui il lavoro non è più né un diritto né un dovere ma un’opportunità di cui ringraziare il datore di lavoro. Non stupisce che per chi ha questa visione del mondo la crescita delle dimissioni sia un mistero insondabile. Tu sostieni invece che siano un sintomo proprio della crisi di questa narrazione del lavoro e della sua moderna organizzazione. Ci spieghi meglio?
Briatore ha detto diverse cose illuminanti di recente. Ha detto che il lavoro povero non esiste: sono attori pagati per dire che sono pagati poco. Ha detto anche che l’abolizione del Reddito di cittadinanza riuscirà finalmente a rimuovere i giovani dal divano e a costringerli a lavorare. Sono frasi che disegnano un contesto ideologico molto preciso, nel quale il lavoro è un favore, un privilegio, un’opportunità per cui bisogna dire grazie. Chi non ringrazia è un problema, una persona ingrata che va punita. Qui c’è una rappresentazione del mondo del lavoro orientata per intero dalla parte della domanda, mentre nessuno dice che l’offerta di lavoro è rigida perché le condizioni sono diventate inaccettabili anche per chi ha bisogno di un lavoro. In questo contesto, la colpa di tutto ciò che non va è stata data a chi lavora. Da questo punto di vista, ricostruire un immaginario working class significa dire che nei luoghi di lavoro c’è un’insofferenza disorganizzata pervasiva e palpabile di cui bisogna tornare a esporre le cause. In ultima analisi, vale sempre ciò che diceva Robert Reich: non c’è carenza di lavoratori, c’è carenza di diritti, di tutele e di condizioni di lavoro adeguate in grado di mettere le persone nelle condizioni di lavorare.
Per restare su questo, una critica di impostazione «marxista ortodossa» nota invece che il lavoro non è mai stato altro che sfruttamento, di conseguenza sarebbe poco radicale guardare al fenomeno delle dimissioni come a una richiesta di lavoro differente da quello oggi prevalente.
Si, c’è chi dice che il lavoro è sempre stato sfruttamento e pensare che sia mai stato un privilegio, come lo ha definito Confindustria, è teoricamente sbagliato. In assoluto, come dargli torto? Tuttavia, ignorare il cambio culturale in cui siamo cresciuti negli ultimi quarant’anni significa essere completamente disinteressati al contesto nel quale la mia generazione e quelle successive sono cresciute. Purtroppo o per fortuna, la storia non si è fermata negli anni Settanta, e ragionare come se il pensiero marxiano fosse diventato egemonico significa, in ultima analisi, non essersi accorti che quella degli anni Settanta è stata una sconfitta, non una vittoria. E quindi non siamo cresciuti in una cultura marxista ma in un contesto reazionario che ci ha insegnato che il lavoro è un privilegio e che per questo bisogna ringraziare. Quindi no, la narrazione dominante non è stata quella di Karl Marx ma quella di Flavio Briatore. È brutto da ammettere, lo so, ma è quanto accaduto e bisogna farci i conti.
Viola, una delle persone che intervisti, cita «l’agire per sottrazione» dello street artist Blu, che cancellò le sue opere a Bologna per impedire che venissero rubate dalle strade e richiuse in un museo per essere rese fruibili solo attraverso il pagamento di un biglietto. Tu crei un ponte tra la pratica di Blu, gli scioperi francesi contro l’aumento dell’età pensionabile e l’esperienza del Collettivo di fabbrica della Gkn. È un accostamento affascinante. In che modo secondo te stanno insieme pratiche apparentemente così diverse tra loro?
Tutte le interviste che ho fatto mettono l’accento sul rifiuto di ciò che toglie dignità. Per molti versi, è un processo che mi ricorda L’uomo in rivolta di Albert Camus. «Che cos’è un uomo in rivolta?», si chiede Camus. È innanzitutto una persona che dice no. Questo no significa che certe forme di sfruttamento sono durate abbastanza, «fin qui, sì, al di là, no», scrive Camus, perché alcune pratiche umilianti sono «andate troppo in là». Camus fa l’esempio di un funzionario che ha ricevuto ordini per tutta la vita ma a un certo punto si rifiuta di riceverne uno ulteriore. Questo no afferma l’esistenza di una frontiera, un confine oltre il quale non si può andare. Il confine mostra che esiste un limite che i datori di lavoro non possono varcare, perché se lo varcano quel comando andrà a ledere la dignità di chi lavora. Le dimissioni nascono lungo questo confine. Ne troviamo cenno in ogni testimonianza. Per Viola, ad esempio, non era accettabile che il lavoro invadesse ogni anfratto della sua vita, per questo decide, dopo aver lungamente tentato di organizzare le colleghe, di sottrarsi per rendere impossibile l’accaparramento delle parti migliori di sé. Per altre persone questo confine ha a che fare con salari troppo bassi o con pratiche vessatorie che diventano inaccettabili. C’è un istinto vitale nelle testimonianze di chi lascia che mostra un desiderio di ribellarsi alla richiesta di sottostare a un continuo tentativo di cattura. In fondo, è quello che sta accadendo in varie parti del mondo. Non sta scritto da nessuna parte che la vita umana debba sottoporsi a rituali di umiliazione per esercitare il semplice diritto di vivere. Non ha senso, nel terzo millennio, continuare a lavorare come un secolo fa. Le norme che regolano il lavoro non sono eterne ed è tempo di arrenderci al fatto che la vita e il pianeta chiedono di lavorare meno, chiedono tempo per respirare e per vivere di più. Lo so che il governo va in un’altra direzione. Proprio per questo l’esigenza viscerale e pervasiva di cambiare rotta mi sembra una buona notizia.
*Giulio Calella, cofondatore e presidente della cooperativa Edizioni Alegre, è editor di Jacobin Italia.
*Francesca Coin, sociologa all’Università di Lancaster, si occupa di lavoro e diseguaglianze sociali.
Fonte: jacobinitalia.it
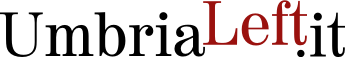



Recent comments
5 anni 46 weeks ago
5 anni 51 weeks ago
5 anni 52 weeks ago
6 anni 2 days ago
6 anni 3 days ago
6 anni 3 days ago
6 anni 5 days ago
6 anni 1 settimana ago
6 anni 1 settimana ago
6 anni 1 settimana ago