L’ultimo lavoro di Alberto Burgio, Senza democrazia. Un’analisi della crisi (Derive Approdi, Roma 2009) è un libro ben fatto, di facile lettura che, con semplicità affronta, un tema complesso come la crisi economica attuale, svelandone le radici reali a le conseguenze sul piano politico e sociale. Il libro contiene un’ enorme massa di dati e citazioni che non ne appesantiscono per nulla la lettura.
Senza democrazia affronta il tema della crisi economica, ma non è un libro di economia.
Il merito di Burgio è infatti quello di far proprio il punto di vista marxiano secondo il quale tutte le categorie economiche (merce, denaro, profitto, inflazione, debito pubblico,…) non sono altro che il modo di funzionamento di rapporti sociali e geopolitici storicamente determinati: rapporti tra capitalisti e lavoratori, tra diversi capitalisti, tra blocchi geopolitici (nazionali o sovrannazionali che siano).
Il libro allora mostra che, è attraverso le avventure delle monete, l’alternarsi di svalutazioni e rivalutazioni, il passaggio dal keynesismo al monetarismo, che si muovono e si realizzano conflitti sociali e interstatali che devono essere nominati per quello che sono se si vuole comprendere il significato profondo degli eventi economici e le loro possibili evoluzioni.
Insomma, come nella migliore tradizione marxista, questo libro non si limita alla semplice considerazione economica, ma ricostruisce una storia unitaria della totalità sociale capitalistica e delle sue strutturali contraddizioni, in cui economia, politica, cultura, cambiamenti geopolitici, sociali e antropologici si fondono in una visione globale che riesce a dare il senso profondo degli avvenimenti.
Per far questo la ricostruzione di Burgio non si limita alla stretta attualità, ma ragiona sul lungo periodo. Riflette sulla crisi attuale inserendola nella storia del capitale e ne ricerca le cause nelle vicende degli ultimi 30 anni. E’ in questo periodo che vanno rintracciate le linee di tendenza che hanno condotto alla crisi attuale.
Burgio individua negli anni ’70 il decennio cruciale in quanto è in quegli anni che, sotto l’incalzare di contraddizioni strutturali, le classi dirigenti occidentali, cambiano strategia e, abbandonato il compromesso keynesiano-fordista, passano all’attacco distruggendo in pochi anni tutte le conquiste che il mondo del lavoro aveva ottenuto nel trentennio precedente.
I tre decenni del dopoguerra, i famosi “trenta gloriosi”, rappresentano l’età dell’oro del capitalismo: attorno agli USA, usciti dalla guerra come potenza egemone, e sulla base della produzione fordista e del compromesso keynesiano si formò uno specifico modo di accumulazione che permise una crescita costante dell’occupazione, della spesa pubblica, dei salari e della produttività. Tutto ciò favorì una crescita dei livelli di democrazia ed un’estensione dei diritti sociali e civili.
Ma questa situazione, già negli anni ’60 cominciò a mostrare i propri limiti: l’avventura del Vietnam assieme alla crescente concorrenza di Germania e Giappone determinò negli USA l’avvio di un processo inflazionistico che ben presto rese insostenibile il Gold exchange standard – il sistema monetario inaugurato a Bretton Woods, basato sui cambi fissi e sulla convertibilità aurea del dollaro. La crisi produsse “un evento di portata storica”: nell’estate del 1971 il presidente Nixon pose fine alla convertibilità aurea del dollaro (che venne dunque svincolato da ogni riferimento alle riserve auree della Banca centrale americana) sostituendolo con il cosiddetto Dollar standard, sistema nel quale il dollaro diviene “moneta di riferimento internazionale su base assolutamente fiduciaria”.
Con questa mossa gli USA rovesciano sul resto del mondo l’onere della sostenibilità dollaro: d’ora in poi non avranno più un “vincolo esterno” potendo acquisire merci e capitali in cambio di una valuta di cui possono stampare a propria discrezione quantità illimitate.
Ma questa mossa, che nell’immediato sembra vincente, con il tempo mostra i suoi effetti negativi: “Il riferimento all’oro poneva infatti un limite all’espansione dell’indebitamento reale degli Stati Uniti”. Nella nuova situazione la possibilità di aumentare all’infinito le importazione toglie stimoli alla produzione USA e determina la trasformazione dell’economia americana in “un’economia basata prevalentemente sulla rendita (finanziaria), sul consumo e sul debito”.
Di fronte a questa situazione che determinava un considerevole calo del tasso di profitto, già alla metà degli anni ’70, il capitale reagisce cancellando il “compromesso keynesiano” e adottando le ricette monetariste di Milton Friedman e della scuola di Chicago: taglio dei salari e precarizzazione del lavoro, riduzione della spesa sociale, privatizzazioni e privilegi fiscali per il capitale”.
Reagan e Thatcher saranno gli alfieri politici di tale svolta. Ma se la reazione reaganiana riuscirà a sconfiggere il movimento operaio e il “socialismo reale”, sul piano economico non riuscirà ad arrestare la tendenza al rallentamento e alla stagnazione.
È di fronte al perdurare della stagnazione che il sistema capitalistico imboccherà, negli anni seguenti, la via di una crescente finanziarizzazione e indirizzerà gran parte dei capitali verso la pura speculazione. In periodi si sovrapproduzione, infatti, la speculazione offre al capitale momentanei canali di sbocco, ma, contemporaneamente accelera lo scoppio della crisi e ne aumenta la virulenza. E questo è quello che puntualmente si è verificato negli ultimi anni, costellati dallo scoppio di innumerevoli “bolle speculative”.
Abbiamo detto che Senza democrazia non è un libro esclusivamente di “economia”, e infatti Burgio pone una grande attenzione alle mutazioni “istituzionali” che hanno seguito le trasformazioni economiche sopra descritte. Il libro sottolinea come le multinazionali, i fondi di investimento e le grandi concentrazioni bancarie, dotate di una forza economica esorbitante, assumono il ruolo di veri e propri “sovrani privati” al pari degli Stati. Si forma un nuovo sistema gerarchizzato dell’economia internazionale “nel quale Stati e capitali forti esercitano un potere di controllo nei confronti degli Stati nazionali più deboli”.
Contro la vulgata che vede il successo del “libero mercato” a danno dello Stato, Senza democrazia mostra che il “neoliberismo” si è affermato grazie alla commistione tra potere economico e potere politico. Il fatto è che per Burgio l’autorità statuale non scompare affatto, ma cambia natura: abdicando alla sua funziona sociale il potere pubblico non si estingue, ma si privatizza. Il netto rifiuto della teorizzazione della “fine dello Stato”, non impedisce a Burgio di vedere le modificazioni che negli ultimi 30 anni il capitale ha imposto al modo di accumulazione e, più specificamente, al rapporto tra potere economico e potere statuale, e di auspicare un’analisi adeguata alla fase da parte delle forze anticapitaliste.
Burgio si domanda come è potuto succedere che la reazione reaganiana abbia vinto così facilmente senza incontrare grandi resistenze. Certo il testo evidenzia il ruolo giocato dal sistema mediatico nel plasmare le opinioni di una società che la crisi economica e i processi di ristrutturazione avevano reso frammentata; così come sottolinea il “potere seduttivo” della merce e del mercato nel favorire l’insorgere di stili di vita basati sul consumo effimero, la ricchezza e l’individualismo. Ma questa vittoria “ideologica” non basta a spiegare quanto è successo. Burgio sottolinea una differenza fra USA ed Europa.
Negli USA, c’è stato un processo di “rivoluzione passiva”, in quanto accanto all’elemento ideologico, l’egemonia del capitale ha operato in parte sul terreno delle condizioni materiali favorendo l’accesso all’indebitamento privato e distribuendo parte delle plusvalenze di Borsa a alla piccola e media borghesia e ad una parte della classe operaia americana, garantendosi, così, il consenso di un nuovo blocco sociale.
Per l’Europa Burgio giudica inapplicabile la nozione gramsciana di “rivoluzione passiva”: la quale implica una reale capacità di “direzione dall’alto” e una parziale soddisfazione delle istanze delle classi subalterne. La mancata resistenza al neoliberismo, in Europa, sembra allora derivare tutta dalla capitolazione della sinistra riformista e dalla sua vocazione trasformistica.
Forse questo aspetto andrebbe maggiormente approfondito. Comprendo e condivido la polemica contro la sinistra riformista, la sua regressione moderata, la sua adesione entusiasta al “libero mercato, l’abbandono della prospettiva di classe e l’assunzione del capitalismo come orizzonte non trascendibile. Ma basta il tradimento dei ceti dirigenti della sinistra riformista per spiegare quanto è successo? C’erano margini per attuare una politica diversa, mantenendo l’impianto riformista? La divisione internazionale del lavoro che vedeva gli USA come mercato di sbocco delle produzioni europee ed asiatiche ha inciso nel determinare la differenza tra le due sponde dell’Atlantico? E l’avventura dell’euro, come va valutata? È stata la risposta del riformismo europeo allo strapotere americano? Tentativo poi annichilito dalle guerre di Clinton nella ex Jugoslavia e di Bush nel Medio Oriente? Sono interrogativi che forse meriterebbero riflessioni più approfondite.
Più che di tradimento parlerei di spaesamento e inadeguatezza del riformismo di fronte al nuovo modo di accumulazione venutosi a creare a partire dagli anni ’80. Forse bisognerà prendere atto che il riformismo ha fatto il suo tempo, che non è all’altezza della sfida in corso. Certo ciò non toglie che le forze riformiste potessero agire diversamente e rendere meno drammatica la sconfitta del movimento operaio.
Quella attuale è secondo Burgio, una crisi di sistema, ma ciò non significa che siamo alla fine del capitalismo.
Da un lato Burgio rileva che il carattere sistemico della crisi difficilmente determinerà un’automatica delegittimazione delle classi dirigenti. All’opposto è molto probabile un’uscita a destra dalla crisi. E’ molto probabile che il capitalismo non solo mantenga le proprie posizioni, ma le estenda trasformando la “Rivoluzione passiva” dell’ultimo trentennio in una vera e propria “restaurazione conservatrice” con profonde conseguenze anche sul piano delle libertà democratiche.
Ma questa eventualità non è priva di contraddizioni. Infatti se da un lato, per uscire dalla crisi, si invoca un rilancio della domanda, dall’altro nessuno si azzarda a porre un freno dalla deflazione salariale. Il fatto è che, posto di fronte alla scelta tra crisi di sovrapproduzione ( da deficit di domanda), come quella attuale, e crisi sociale (da piena occupazione e alti salari), come quella degli anni ’70, il capitale sceglie il male minore, cioè la prima, quella che non mette in discussione il suo potere.
Perché alla fine , come ricordavo prima, dietro alle variabili economiche ci sono i rapporti sociali, c’è la lotta di classe, e l’obiettivo del capitale è sempre quello della completa subordinazione del lavoro dipendente.
Dall’altro, Burgio rileva che la partita non è ancora chiusa, si profila la possibilità, per quanto flebile, di una fuoriuscita dal capitalismo la cui insostenibilità sociale, economica ed ecologica è ormai sotto gli occhi di tutti. Questa seconda possibilità, che è ancora tutta da costruire, si basa su alcuni elementi di segno progressivo che la crisi sta facendo emergere e che Burgio individua nel ritorno alla centralità dello Stato e della Politica, alla centralità della produzione (dopo la sbornia della finanza) e quindi alla possibile riemersione del conflitto capitale/lavoro, nella crisi del dominio USA e in una nuova struttura del quadro geopolitico internazionale.
Sugli esiti di questa possibilità, Burgio non si avventura in alcuna previsione, ben consapevole del fatto che tutto dipenderà dall’evoluzione dei rapporti di forza in campo e dalla capacità e volontà della sinistra anticapitalista di sviluppare e mettere a frutto gli elementi progressivi sopra citati.
Insomma Senza democrazia è un libro importante che offre gli strumenti storici e teorici per analizzare la crisi attuale e le sue possibili evoluzioni. Un libro che consiglio vivamente a chi non si rassegna, a chi pensa che “un altro mondo è ancora possibile”.
Stefano Pecugi
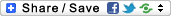


Recent comments
5 anni 17 weeks ago
5 anni 23 weeks ago
5 anni 23 weeks ago
5 anni 23 weeks ago
5 anni 23 weeks ago
5 anni 23 weeks ago
5 anni 24 weeks ago
5 anni 24 weeks ago
5 anni 25 weeks ago
5 anni 25 weeks ago