In una campagna elettorale già così poco attenta alle tematiche europee sta passando quasi del tutto inosservato il fatto che con la prossima legislatura, sempre che sia finalmente ratificato il Trattato di Lisbona, l'Europarlamento assumerà nuovi, estesi poteri di co-decisione legislativa negli ultimi settori in cui aveva ancora solo un ruolo consultivo: la politica agricola comune (Pac), compreso il suo finanziamento, e la politica comune della Pesca; i regolamenti specifici dei Fondi regionali e di coesione; la dimensione europea gli Affari interni e di giustizia (immigrazione, visti, asilo, cooperazione giudiziaria e di polizia) e alcune applicazioni del diritto penale.
L'Assemblea di Strasburgo, inoltre, parteciperà attivamente alla nomina del presidente della Commissione europea. Finora poteva solo approvare o bocciare la scelta dei capi di governo dell'Ue; con Lisbona, la designazione del nuovo capo dell'Esecutivo comunitario dovrà essere fatta "sulla base dei risultati delle elezioni europee".
In sostanza, questo significa che i capi di governo dovranno consultare i gruppi politici dell'Europarlamento prima ancora di designare il loro candidato alla presidenza della Commissione. Il presidente designato dovrà poi essere approvato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri (e non solo a maggioranza dei presenti al voto); una circostanza, questa, che rafforza le coalizioni rispetto al gruppo di maggioranza relativa. Anche la nomina dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, che sarà anche vicepresidente della Commissione, sarà soggetta al consenso dell'Europarlamento.
Il fatto che l'Europarlamento possa finalmente co-decidere le misure della Pac e il loro finanziamento significa che l'Assemblea di Strasburgo assume un ruolo praticamente alla pari con il Consiglio Ue anche sull'approvazione del bilancio annuale.
Le spese agricole rappresentano infatti la massima parte di quel capitolo del bilancio Ue chiamato "spese non obbligatorie", su cui finora il Parlamento non aveva potere decisionale e non poteva, eventualmente, opporre il proprio veto.
Importante è anche il nuovo potere che l'Europarlamento assume sul finanziamento delle misure specifiche delle politiche regionali e di coesione (destinati alle aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale).
La parità pressoché completa raggiunta con Lisbona dall'Europarlamento rispetto al Consiglio Ue nella gestione finanziaria annuale risalta ancora di più se si considera che la Pac rappresenta tradizionalmente la prima voce di spesa dell'Unione (anche se è passato dal 75% del totale di 25 anni fa al 43% oggi) e che le politiche regionali sono la seconda voce di spesa più importante (attualmente il 36% del totale).
Il potere del Consiglio (ovvero dei governi dei Ventisette) resta invece senza contrappesi per quanto riguarda le decisioni sulle 'prospettive finanziarie' ovvero il quadro finanziario pluriennale comunitario, che stabilisce le risorse dedicate dagli Stati membri all'Ue, e le eventuali modifiche del sistema delle 'risorse proprie', cioè i prelievi diretti (sullo zucchero, alle dogane, e una parte dell'Iva) destinati al finanziamento del bilancio.
Una novità di grande rilevanza per i cittadini sarà la 'comunitarizzazione' degli Affari interni e di giustizia, un settore che era rimasto per anni nel limbo del cosiddetto 'terzo pilastro', in cui le decisioni sono prese all'unanimità dagli Stati membri, la Commissione europea non ha poteri di controllo dell'esecuzione delle misure, e l'Europarlamento non ha praticamente alcuna voce in capitolo. Con Lisbona, il Parlamento europeo diventerà co-legislatore nelle politiche dei visti, dell'asilo (in particolare riguardo alle condizioni per l'accoglienza dei richiedenti), dell'immigrazione legale (comprese le condizioni di ingresso e di residenza), nonché nella cooperazione giudiziaria in ambito penale (Eurojust), e nella cooperazione di polizia (Europol), in particolare per la.
Lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo (entrambi fenomeni transfrontalieri).
Il trattato di Lisbona introdurrà anche alcuni settori completamente nuovi, non inclusi prima fra le competenze comunitarie, e che verranno soggetti alla procedura di co-decisione: la sicurezza energetica (ovvero le decisioni sull'approvvigionamento, mentre l'Ue è già competente sul mercato interno), i controlli alle frontiere, alcuno aspetti della politica dello sport, i servizi di interesse economico generale, la protezione dei dati personali, alcuni aspetti delle politiche d'immigrazione (lotta alla tratta di esseri umani e promozione dell'integrazione), i diritti di proprietà intellettuale comuni, alcuni aspetti della sanità pubblica (misure che definiscano elevati standard di qualità, ma non l'armonizzazione), politica spaziale e turismo.
Oltre alle già citate prospettive finanziarie, i settori che restano al di fuori della portata del Parlamento europeo, e sui quali le decisioni continueranno a essere prese all'unanimità in Consiglio Ue (sebbene vi sia la possibilità di 'cooperazioni rafforzate' fra gruppi di paesi, che potrebbero darsi regole diverse), sono sostanzialmente tre: la Politica estera e di sicurezza comune, la fiscalità e gli aspetti di politica sociale non coperti dalle competenze Ue (che riguardano la libera circolazione dei lavoratori, la non discriminazione, la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, gli standard minimi per le condizioni di lavoro).
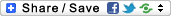


Recent comments
5 anni 8 weeks ago
5 anni 13 weeks ago
5 anni 14 weeks ago
5 anni 14 weeks ago
5 anni 14 weeks ago
5 anni 14 weeks ago
5 anni 15 weeks ago
5 anni 15 weeks ago
5 anni 15 weeks ago
5 anni 15 weeks ago