Un'anima in pena!

di Anselmo Pagani.
Come altro definire Giacomo Leopardi, morto a Napoli il 14 giugno del 1837 a soli 39 anni d'età e da tanti considerato il più importante poeta italiano dell'Ottocento, se in quella sorta di epigrafe sulla sua esistenza che fu il Canto "A se stesso", rivolgendosi al proprio cuore, scrisse: "Posa per sempre./ Assai palpitasti. Non val cosa nessuna / i moti tuoi, né di sospiri è degna / la terra. Amaro e noia / la vita, altro mai nulla; e fango è il mondo".
Perché tanto pessimismo e disperazione? Non vale la pena di vivere? È proprio vero che "al gener nostro il fato / non donò che il morire"?
Eppure Giacomo denotò fin da bambino di possedere grandi talenti, in particolare intelligenza e velocità d'apprendimento fuori dal comune, oltre che una capacità d'applicazione eccezionale che rese superfluo il lavoro dei precettori prepostigli da suo padre Monaldo, un reazionario ideologicamente agli antipodi delle idee illuministiche che, anche col concorso della bigotta madre Adelaide Antici, in casa Leopardi a Recanati non ebbero mai accesso.
Primo di una numerosa nidiata di fratelli e sorelle cresciuti in maniera spartana, come unico divertimento giovanile ebbe quello di tuffarsi nello "studio matto e disperatissimo", potendo in ciò contare sulla biblioteca paterna composta da oltre ventimila volumi specialmente classici.
Così Giacomo apprese da autodidatta non solo il greco, il latino e l'ebraico, ma anche lingue correnti quali il francese, lo spagnolo e l'inglese.
Compose il suo primo sonetto a soli 11 anni per poi dedicarsi alle traduzioni dei classici greci e latini, per i quali nutrì sempre una venerazione che lo portò ad affermare che "noi non abbiamo mai potuto pareggiare gli antichi", con la precisazione che le civiltà greca e latina sono "inarrivate ed inarrivabili nelle lettere e belle arti e pur consideranti le une e le altre come passatempi".
In altre parole, gli antichi producevano capolavori letterari ed artistici quasi per "hobby" e senza sforzi, anzi in realtà occupandosi d'altro. Con poco impegno e scarsi mezzi realizzavano infatti tanto, mentre i suoi (e nostri?) contemporanei facevano l'esatto contrario perché, pur mettendocela tutta, concludevano poco o nulla.
Anche a causa di tutto questo stare ricurvo sui libri purtroppo, la già precaria salute di Giacomo, che un "Adone" non lo fu mai, subì fin dalla gioventù un sensibile peggioramento.
Affetto da scoliosi, la schiena gli si incurvò in una doppia gobba che fu a sua volta causa di spasmi respiratori e problemi cardiaci, il tutto peggiorato da un'altezza che raggiungeva appena il metro e mezzo circa.
Non tardarono poi a manifestarsi gravi problemi di vista e una tubercolosi ossea che lo tormentò fin da ragazzo.
Un simile quadro clinico non poté non influire sul suo profilo psicologico. Fu infatti sempre pervaso da un generale pessimismo ed umor nero, appena intervallato da momentanei scoppi d'euforia, ma vieppiù aggravato dalla constatazione che le sue "simpatie" femminili mantenevano verso di lui la più totale indifferenza, mentre i ragazzacci del borgo natio, pronti come sempre a prendere di mira il "secchione" di turno, lo bersagliavano con pesanti lazzi e canzonature.
Quando finalmente riuscì ad affrancarsi dalla famiglia e prendere il largo da Recanati, peregrinò fra Milano, Bologna, Roma e Firenze, senza trovare pace, ma almeno facendosi conoscere ed apprezzare, tanto da procurarsi i primi contratti con editori vari ed a sua volta conoscendo scrittori già illustri come l'anziano Monti e il giovane Manzoni, andato a Firenze per "lavare i panni in Arno".
Dal 1817 e fino al 1832 tenne il suo famoso Zibaldone, una sorta di diario intimo pieno di spunti e riflessioni personali. Sempre da quell'anno, messe da parte le traduzioni dei classici, si dedicò quasi esclusivamente alle poesie, regalandoci le sue perle più belle che sarebbero poi state raccolte e pubblicate negli Idilli.
"L'infinito", "La sera del di' di festa", "La quiete dopo la tempesta", "Il sabato del villaggio", "Il passero solitario", "A Silvia": ognuno di noi fra tante bellissime liriche ha la sua preferita perché, come lo stesso Leopardi ci ricorda, la poesia aggiunge "un filo alla tela brevissima della nostra vita. Essa ci rinfresca e accresce la vitalità".
Quel poco di sollievo che in vita il nostro riuscì a trovare, se lo diede rifugiandosi nella poesia, non senza però accogliere la morte, sopravvenuta per un'idropisia polmonare, alla stregua di una liberatrice poiché per lui addirittura "è funesto a chi nasce il di’ natale".
Immagine “Ritratto di Giacomo Leopardi”, di A. Ferrazzi, 1820, Museo di Palazzo Leopardi, Recanati.
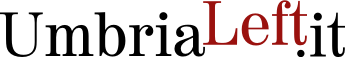



Recent comments
4 anni 15 weeks ago
4 anni 20 weeks ago
4 anni 20 weeks ago
4 anni 20 weeks ago
4 anni 21 weeks ago
4 anni 21 weeks ago
4 anni 21 weeks ago
4 anni 21 weeks ago
4 anni 22 weeks ago
4 anni 22 weeks ago