Soldi, affari e malaffare nella Roma antica. Recensione di Maria Pellegrini.

di Maria Pellegrini.
Un racconto avvincente di come funzionava il mondo degli affari, l’attività dei banchieri, la piaga dei debitori, la fortuna di commercianti e speculatori nei mille e duecento anni della storia di Roma, dalla fondazione alla caduta dell’Impero, lo troviamo in un volume dal titolo molto significativo “Soldi, affari e malaffare nella Roma antica” (ed. Mursia, pp. 250, € 16,00), di Antonietta Dosi e François Schnell, che nella loro carriera vantano di essere stati oltre che autori di saggi e studi sul mondo antico classico, anche Direttori di Istituti di Cultura, l’una ad Alessandria d’Egitto, l’altro di vari Istituti culturali francesi in Brasile, Grecia e Polonia.
Sarà sufficiente sfogliare l’Indice del libro per rivelarne tutta la ricchezza di argomenti trattati: dalla storia della moneta ai cambiavalute e i banchieri; dalla ricchezza ottenuta con i bottini di guerra alla gestione delle tenute agricole e alle rendite da queste ricavate; dalle carriere pubbliche esercitate da alcuni con rigore e onestà e da altri con disonestà come Verre, governatore rapace in Sicilia; dai guadagni ottenuti con le professioni (medici, avvocati, insegnanti) ad altre fonti provenienti da doti matrimoniali, testamenti, prostituzione, scommesse nelle gare sportive.
Nel I secolo a. C. fu celebre il processo contro Gaio Verre, ex governatore della Sicilia, i cui capi di accusa erano: concussione, peculato, violenza. Durante il suo mandato aveva sfruttato la provincia con incredibile rapacità.
Ma a fine mandato nel gennaio del 70 a. C., ben sessantaquattro città dell’isola, saccheggiate e stremate dalla sua cupidigia, decisero di ricorrere al Foro Romano per intentare contro di lui una causa per corruzione e concussione affidando il patrocinio dell’accusa a Cicerone. Verre, come era in uso tra i governatori, era andato in Sicilia per arricchirsi e ciò poteva essere accettabile, ma aveva oltrepassato ogni limite di decenza. Cicerone mostrò con metodo, con precise testimonianze e documenti che nei suoi anni in Sicilia Verre aveva ammassato l’enorme somma di 40.000.000 di sesterzi.
Verre costituiva un caso tutt’altro che isolato, i governatori delle provincie e gli alti gradi dell’amministrazione periferica, nonostante il generoso appannaggio ricevuto, spesso approfittavano della propria posizione per danneggiare le popolazioni soggette a Roma. Era costume diffuso depredare le province dei loro tesori d’arte e arricchirsi con ogni mezzo lecito e illecito che consentisse loro di ripagarsi le enormi spese sostenute per la candidatura.
La storia dell’antica Roma documenta che il fenomeno della corruzione ebbe dimensioni anche superiori a quelle dei nostri tempi con precise testimonianze di corruzione elettorale, brogli, concussione, peculato, appalti e tangenti, vendita di posti e di cariche, manovre per comprare i giudici. Si acquistavano voti, cariche pubbliche, inferiori e alte, posti nell’amministrazione e nell’esercito. Fu proprio questa vena corruttiva a decretare il declino della civiltà romana.
Niente di nuovo sotto il sole, verrebbe in mente di affermare quando si legge quanto è stato tramandato da storici e poeti sulla contrapposta condizione di ricchi e poveri, «La condizione fondamentale per essere ricchi e diventarlo sempre di più era, allora come oggi, quella di possedere una sfrenata ambizione e cupidigia per il denaro», scrivono gli Autori. Celebre per la sua ricchezza fu Licinio Crasso un politico dell’età di Cesare. Fonte del suo arricchimento era il prestito a interesse e l’acquisto di beni venduti all’asta durante le proscrizioni. Si dedicò anche a speculazioni immobiliari: comprava a un costo irrisorio le case distrutte dagli incendi o crollate e le ricostruiva rivendendole o affittandole a caro prezzo. Anche tra gli imperatori c’erano gli onesti e retti come Vespasiano, però avido di danaro che spillava ai cittadini tassandoli tanto che il figlio Tito gli rimproverava di aver tassato pure le urine.
C’erano anche personaggi ricchi amanti del cibo per il quale spendevano fortune come Lucullo e Apicio. Augusto non riuscì ad arginare l’eccessivo fasto nel cibo e nelle spese voluttuarie di tanti arricchiti per tornare alla temperanza e semplicità delle origini. Perciò la sontuosità del banchetto romano crebbe tanto che divenne proverbiale: si dice tutt’oggi “pranzo luculliano” come sinonimo di un banchetto abbondante, sontuoso e raffinato, alludendo a Lucullo, generale romano, vissuto nel I secolo a. C. e passato alla storia non per le glorie belliche ma per i pranzi sfarzosi a base di carni pregiate, come i pavoni, i cinghiali, i tordi, e i pesci più rari.
Al tempo di Tiberio, successore di Augusto, visse Apicio (14-37 d.C.), un patrizio gaudente e buongustaio, appassionato di particolarità gastronomiche, noto per un ricettario pervenuto non nella struttura originaria, nel quale si deducono le sue predilezioni per la selvaggina esotica; intratteneva infatti i suoi ospiti offrendo il pappagallo o i fenicotteri arrostiti, l’utero di scrofa, i ghiri farciti. Secondo Plinio il Vecchio è stato «il più grande tra tutti gli scialacquatori», e a lui andrebbe attribuita l’invenzione del foie gras, che i romani chiamano ficatum, perché tratto da oche ingrassate con fichi.
Come tramanda Plinio, per una triglia di quattro libbre e mezzo egli era pronto a pagare 5000 sesterzi; anzi era pronto a preparare una nave a Minturno, dove soggiornava, e a partire diretto in Libia per trovare nel suo mare favolosi pesci.
Quando si accorse che il suo patrimonio, ridotto a soli cento milioni di sesterzi, non gli avrebbe consentito più di mantenere il tenore di vita cui si era abituato si uccise: La sua morte per veleno fu interpretata dai primi cristiani e dai filosofi stoici come una punizione esemplare, perché con il suo stile di vita e con il suo libro di cucina, De re coquinaria (“L’arte culinaria”), costituiva un pericolo per la salvezza morale della società.
Roma, in età imperiale soprattutto con i successori di Augusto divenne una città che offriva possibilità di migliorare la propria condizione ma a pochi riusciva. Petronio, autore vissuto nell’età di Nerone nel “Satyricon”, presenta un campione di quei fortunati che sono riusciti ad arricchirsi: Trimalcione, un liberto che vuole stupire i suoi ospiti con una cena dove offre un’interminabile serie di portate, una più stravagante dell’altra, presentate con una coreografia teatrale. Durante la famosa e lussuosa “Cena” narrata nel Satyricon (un documento prezioso per comprendere l’ambiente degli arricchiti del I secolo d. C.) si vanta di essere passato dalla condizione misera di schiavo a quella di ricco possidente.
Nelle opere degli scrittori latini abbiamo una ricca documentazione anche relativa ai poveri, agli schiavi, nei confronti dei quali per la mentalità dominante. lo schiavo è un bene, una “cosa”, uno strumento di lavoro dotato di voce, è una ricchezza per i grandi latifondisti, come Catone il Censore, Varrone, Columella.
Nel corso degli anni si assiste sempre più spesso alla grande disparità tra poveri e ricchi alla quale si cerca di rimediare con l’assistenza pubblica ai privi di ogni mezzo di sostentamento, alle leggi per moderare il lusso.
Professioni per arricchirsi erano quelle di avvocato e medico. Il poeta satirico, Marziale, consigliava a un amico: «Vuoi essere ricco? Fai l’avvocato». La carriera di avvocato costituiva un trampolino di lancio per la carriera politica.
La categoria dei medici fu spesso soggetta a critiche quando arrivarono dalla Grecia a Roma, medici prima accolti come salvatori del genere umano, poi ne furono delusi sul piano professionale e morale spesso rivelandosi ciarlatani o truffatori. Ma dopo le guerre vittoriose di Roma in Grecia e in Oriente cominciarono ad arrivare e affermarsi medici di valore che in breve ebbero molti privilegi come l’esenzione dal pagamento delle tasse: presto accumularono fortune e furono spesso citati nei testamenti. Va comunque ricordato che tra i medici venuti a Roma, molti furono apprezzati per serietà e preparazione, tanto che Cesare concesse loro la cittadinanza romana; ad Antonio Musa, medico personale di Augusto, fu addirittura dedicata una statua sul Palatino. In età imperiale i medici riuscirono a ottenere il riconoscimento del loro status, per il quale da lungo tempo lottavano. Sotto Vespasiano l’insegnamento della medicina era addirittura riconosciuto dallo Stato e agli insegnanti era corrisposto, come per altre discipline, uno stipendio.
Tra i vari capitoli del volume qui citati solo sommariamente, interessante è quello sulla moneta romana con il quale s’inizia la trattazione. Gli scambi commerciali erano fondati nei primi secoli in natura, poi con lingotti di bronzo; gli scambi commerciali si basavano su lingotti di bronzo del peso di una libbra (327 grammi). Il lingotto era detto “pecunia” perché il suo valore era l'equivalente di un capo di bestiame “pecus”. Dal bronzo (in latino “aes”) prese nome la prima moneta romana, l'asse. Ma nel 209 a.C. fu necessario mettere mano alle riserve auree. Era in corso lo scontro vitale con Cartagine e vennero fuse ben 4 mila libbre d'oro, ricavandone monete per pagare le truppe e procurare i viveri. Da allora le monete vennero coniate con raffigurazioni di conquiste militari, di divinità, di lotte per il potere, inaugurazione di una via o di monumenti, sicché nella loro sequenza permettono di leggere la storia di Roma. Giulio Cesare fu il primo a far imprimere la sua immagine sulle monete.
Gli Autori guidano il lettore con competenza e rigore a entrare nel mondo della storia di Roma quando questa si è allontanata dalle virtù degli antichi tempi del Repubblica per entrare in un mondo dove campeggia la corruzione, la speculazione, gli affari e tante attività nocive alla società. Una ricca bibliografia, pregevoli illustrazioni, note esplicative alla fine di ogni capitolo, rendono questo volume prezioso per capire anche il rapporto dei Romani con il denaro che, come scrive Sallustio, «è all’origine di tutti i mali».
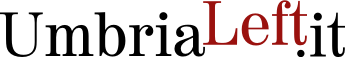



Recent comments
4 anni 45 weeks ago
4 anni 50 weeks ago
4 anni 51 weeks ago
4 anni 51 weeks ago
4 anni 51 weeks ago
4 anni 51 weeks ago
5 anni 4 ore ago
5 anni 3 days ago
5 anni 5 days ago
5 anni 5 days ago