Lo scontro Usa-Cina e la trappola di Tucidide.

di Alfonso Gianni.
Viviamo una fase della storia contrassegnata da un processo di transizione egemonica mondiale da Ovest verso Est. Il cd “secolo americano” è agli sgoccioli, mentre emerge con sempre maggiore forza la potenza della Cina. Non si può certamente dire che la superiorità statunitense in campo tecnologico, economico, diplomatico e soprattutto militare sia stata già surclassata, ma certamente in tutti questi campi - persino in quello militare, con una accelerazione in questo caso più recente – le distanze tra le due grandi potenze si sono di molto accorciate.
Basta qualche semplice dato per rendere evidente questa tendenza. Negli anni settanta del secolo scorso, quando terminavano i cd “trenta anni gloriosi” del capitalismo occidentale, il settore industriale cinese non era minimamente competitivo. Ora la Cina è il secondo più grande produttore industriale del mondo. In appena due decenni (1990-2010) un sesto della produzione industriale mondiale si è spostato in Cina, in un quadro dove, prima della grande crisi, la quantità complessiva della produzione globale era in aumento.
Ma non è solo la quantità che conta. Comincia a pesare la qualità, ovvero il tasso di tecnologia incorporata nelle produzioni cinesi. Se ancora alla fine del secolo scorso la Cina poteva essere considerata la fabbrica del mondo, che produceva merci di scarsa qualità o componenti per prodotti destinati ad essere ultimati altrove per essere venduti a basso prezzo nei paesi più sviluppati, anche per permettere l’acquisto a chi viveva di basse retribuzioni (cioè il “sistema Walmart”, la più grande catena di distribuzione nel mondo fondata nel 1962 dallo statunitense Sam Walton), oggi il quadro è completamente mutato. In ogni settore la competizione cinese si fa sentire anche nel campo tecnologico, continuando nel contempo ad avvantaggiarsi di bassi costi di produzione, garantiti da salari bassissimi che però negli ultimi anni hanno preso a salire cominciando a mettere in discussione concretamente il vecchio modello anche dall’interno del grande paese asiatico.
Le differenza del Pil per abitante fra Cina e Usa è ancora forte: non raggiunge neppure il 15% di quello statunitense. Tuttavia la crescita della Cina ha permesso di ridurre le distanze tra paesi sviluppati e quelli emergenti in modo sempre più evidente, in un contesto dove però sono aumentate ed evidenziate le differenze interne sia ai paesi del capitalismo maturo, sia in quelli emergenti o già emersi, compresa la Cina stessa. Conseguentemente è cambiata la distribuzione delle quote di Pil mondiale. Dal 1990 la quota del Pil dei paesi del G7 sul totale mondiale è scesa da due terzi a meno della metà. Questa perdita è andata a 11 paesi “crescenti”, ma in modo diseguale, poiché la Cina se ne è accaparrata circa i due terzi.
La Cina, anche grazie ad una politica previdente del proprio governo, non ha subito gravi contraccolpi dalla crisi mondiale che, tra alti e bassi, perdura dal 2007. Certamente la sua crescita impetuosa ha subito un rallentamento. Tuttavia il secondo trimestre del 2018 faceva registrare un tasso di crescita del 6,7% superiore alle stesse previsioni che si erano assestate due decimali al di sotto. Questo dato si accompagna anche a un mutamento nei meccanismi di accumulazione dell’economia cinese. Non sono più le esportazioni l’unico motore della crescita, ma il consumo interno (per il 43,4%) e gli investimenti (per il 40% del Pil). Una scelta precisa, sancita anche dall’ultimo congresso del Pcc, a favore dello sviluppo del mercato interno.
Nello stesso tempo i rubinetti dei finanziamenti pubblici aperti con generosità nel biennio 2007-2008 per respingere i guasti della crisi mondiale, necessitano di una qualche stretta per non esagerare nell’indebitamento. Tuttavia un mercato interno fatto da 1,4 miliardi di potenziali consumatori può evitare alla Cina il rischio di una depressione come avvenne in Giappone lungo gli anni ’80. Anzi, come è noto, il governo cinese guarda con fiducia agli anni futuri e punta con decisione sulla nuova via della seta - Belt and Road Initiative (Bri) -, un progetto ambizioso e imponente, che prevede una serie di snodi portuali e ferroviari disegnati sull’antica traccia terrestre e nuove vie marittime, a cui affidare l’obiettivo di una egemonia mondiale non solo di carattere economico.
L’amministrazione Trump si è posta il compito di frenare l’avanzata cinese e recuperare il terreno perduto dagli Usa. Non c’è dubbio che dietro la contesa sul nucleare nordcoreano e la guerra dei dazi ci sia il disegno di contenere e possibilmente fare retrocedere la crescente forza del Dragone. Lo ha detto lo stesso Trump, nel suo solito stile spiccio, in un twitter del 18 agosto di quest’anno. “Tutti gli imbecilli che si concentrano sulla Russia farebbero meglio a preoccuparsi della Cina”. Anche se poi la linea di politica estera di Trump appare spesso ondivaga e umorale. Prova ne sia la telefonata definita distensiva di qualche giorno fa del presidente americano a Xi Jinping in vista del G20 in Argentina. Intanto Washington incassa il prevalere di forze reazionarie nel suo vecchio “giardino di casa”, ovvero l’America Latina, come dimostra purtroppo la netta vittoria di Bolsonaro in Brasile, preparata dal “colpo di stato” giudiziario contro Lula.
Per ora lo scontro Usa-Cina è concentrato sul terreno economico, cioè sulla guerra commerciale promossa dall’aggressività statunitense. Trump può indubbiamente contare su un elemento di forza: il buon andamento dell’economia americana, frutto più della politica del suo predecessore che suo. Anche se la sua linea di riduzione delle tassazioni sta ringalluzzendo non poco le imprese americane.
Tuttavia il bilancio del primo impatto della nuova guerra commerciale non appare devastante su nessuna delle due economie. Trump sta spingendo in alto le tariffe (secondo i dati di fine settembre) su oltre 200 miliardi di dollari di importazioni. La risposta cinese si mantiene cauta, mostrando di scegliere la tattica di assorbire il colpo, più che lanciarsi in una potente controffensiva. Infatti da parte cinese sono stati colpiti “solo” 60 miliardi di beni Usa. Del resto il complesso delle importazioni cinesi dagli Usa ammontano a 130 miliardi, distribuiti prevalentemente su beni agroalimentari, materie prime ed energia. La competizione, dal punto di vista cinese, non può quindi limitarsi ai dazi.
Infatti un’altra carta importante nelle mani del Dragone è l’asse valutario. La Cina potrebbe lasciare deprezzare lo Yuan rispetto al Dollaro, annullando di fatto gli aumenti di prezzo dovuti ai dazi. Ma il governo cinese non appare per ora attratto da questa “facile” prospettiva. La ragione è che è più importante, considerando le cose con uno sguardo di lungo periodo, mantenere la divisa monetaria cinese sostanzialmente stabile per aumentare la fiducia che gli operatori internazionali hanno in essa. Il suo utilizzo negli scambi internazionali è di molto aumentato da quando nel 2015 la divisa cinese è entrata a fare parte del paniere delle valute di riserva del Fondo monetario internazionale. In Africa, terra di conquista cinese negli ultimi decenni, lo Yuan è addirittura predominante avendo tassi di utilizzo che superano il 50%. Secondo diverse stime l’effetto dell’innalzamento dei dazi da parte statunitense, anche se destinato ad aumentare nel 2019, influirebbe negativamente sul Pil cinese dello 0,9% all’anno, un effetto tutto sommato controllabile attraverso politiche fiscali e monetarie che il governo cinese può mettere in atto.
Alla Cina conviene di più, per ora, aspettare, secondo un antico detto confuciano, sulla riva del fiume che passi il cadavere del suo nemico, ovvero, in questo caso, che la guerra dei dazi si ritorca contro i consumatori americani. Per il momento, vista la crescita dei redditi negli Usa, neppure una tale scelta provoca effetti devastanti. Ma li potrebbe causare se si avverassero le previsioni di molti economisti, cioè di una nuova fase di crisi e recessione a livello mondiale capace di ripercuotersi pesantemente negli Usa, anche se non dovesse partire, come nel 2007, dall’interno del paese nordamericano.
Ma siamo appena agli inizi. Cosa ci riserverà il futuro è difficile a dirsi. L’esito stesso delle imminenti elezioni di midterm negli Usa potrebbe portare ad un indebolimento sensibile della leadership di Trump. Ma nello stesso tempo non è detto che questi non cerchi di recuperare il terreno perduto con una politica estera ancora più aggressiva. Quello che è certo è che lo scontro fra la grande potenza declinante, gli Usa, e quella in grande sviluppo, la Cina, è destinato ad occupare le vicende politiche mondiali dei prossimi anni nelle più diverse forme.
Il problema è che non scatti la cd “trappola di Tucidide”. Il grande storico greco osservò che quello che rese inevitabile la guerra fra Sparta ed Atene fu la crescita di quest’ultima e la paura che questo generò a Sparta. Se fra Usa e Cina succedesse la stessa cosa non assisteremmo più ad una guerra mondiale a pezzetti, come ebbe a dire papa Francesco riguardo alla situazione attuale, ma a un nuovo conflitto mondiale generalizzato. E’ quello che l’umanità e il nostro pianeta non potrebbero sopportare, visto il micidiale carattere distruttivo dei moderni armamenti. Anche per questa ragione abbiamo bisogno di un’Unione europea che svolga un ruolo attivo di pace nel mondo. Ma perché ciò accada c’è bisogno di riscrivere i trattati e dare una Costituzione all’Europa, affinché sia la volontà dei popoli a prevalere su quella delle elite economiche. Un tema che dovrà essere messo al centro delle prossime elezioni europee di maggio.
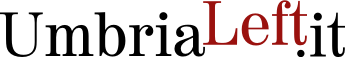



Recent comments
4 anni 39 weeks ago
4 anni 44 weeks ago
4 anni 45 weeks ago
4 anni 45 weeks ago
4 anni 45 weeks ago
4 anni 45 weeks ago
4 anni 45 weeks ago
4 anni 46 weeks ago
4 anni 46 weeks ago
4 anni 46 weeks ago