Valore e significato della coerenza

Luca Canali
Preferisco non ricordare chi abbia inventato o pronunziato per primo la frase (espressione di un pragmatismo non solo cinico ma anche diseducativo): «La coerenza è la virtù degli imbecilli». A un giudizio ponderato su di essa è necessario giungere dopo una rigorosa riflessione soprattutto linguistica, magari tenendo conto anche di due libri usciti recentemente per le edizioni Einaudi, La manipolazione delle parole di Gianrico Carofiglio e Sulla lingua del tempo presente di Gustavo Zagrebelsky. Il fatto che si senta oggi la necessità di discutere, in sede non filologica, ma di alta divulgazione, sulle parole come fondamentale mezzo di comunicazione, polemica o solidale, fra uomini di tutti i livelli sociali, indica il crescente e persino angoscioso bisogno d'una assoluta e reciproca chiarezza demistificante in tutte le occasioni della vita politica, sociale e interpersonale: chiarezza che diventa obbligo in periodi cruciali, confusi e corrotti, qual è purtroppo il nostro attuale. Eccoci dunque al punto: la parola coerenza non significa cieca ostinazione nel perseguire le proprie opinioni, convinzioni, e pratiche trasformazioni di esse in azioni, anche quando in esse si manifesti il motivato sospetto di un pericoloso errore, o, peggio, la consapevolezza di una propria inconfessabile malafede. Coerenza significa invece logico svolgimento di una ideazione e di un comportamento che tengano conto delle inevitabili, e talvolta necessarie varianti che il semplice "mestiere di vivere" comporta, purché, tuttavia, questo processo non lineare non contrasti con il nucleo iniziale ma centrale della propria moralità, dalla quale discendano tutti gli impegni concreti nella propria vita personale, nel proprio aggregato sociale, e nella propria condotta politica. Cioè: cambiare idea si può, ma solo quando il cambiamento avvenga lontano da sollecitazioni di un mercenario opportunismo che attinga dalla più becera astuzia la capacità di suscitare - ma solo nei meno corruttibili - almeno un briciolo di disprezzo di se stessi.
Si è parlato di opportunismo mercenario: mercenari erano, com'è noto, quei combattenti senza patria e senza onore che usavano la propria vita come merce di scambio: il che di solito fruttava loro danaro, molto danaro, o qualche beneficio esistenziale che con quel danaro si poteva facilmente ottenere: una migliore collocazione sociale, una promozione nei ranghi della milizia o della società, femmine di lusso, o semplicemente potere: quel potere che così era considerato dalla vecchia mafia: «Comandare è meglio che fottere».
In questi giorni nel nostro Paese v'è un grande agitarsi nel mercato di uomini, o, meglio, di politici che vendono il proprio voto, divenuto mercanzia ogni giorno più redditizia, perché all'appressarsi di una data forse decisiva, ma sicuramente importante della vicenda politica italica, cresce l'ansia di quanti potrebbero perdere quel potere che ha loro permesso di governare per anni a proprio personale vantaggio e insieme a proprio diletto, un Paese come il nostro che ha invece un bisogno febbrile di essere governato con altruismo, onestà, competenza, dignità personale.
Ma i mercenari, per questo timor panico dei loro reclutatori, costano (guadagnano) ogni giorno di più, fra lo sconcerto ma anche la distruttiva rassegnazione di quanti, a torto, credono ormai impossibile qualsiasi mutamento pur pacificamente rivoluzionario, cioè civilmente energico e coerente con quell'originario nucleo di moralità attiva che non può essere stato annientato in nessuna creatura umana, e, meglio, in nessun cittadino degno di questo nome e non disposto a fare di sé vergognosa mercanzia. Soltanto la lotta democratica ma robusta di cittadini di tal fatta, cioè dalla parte sana della Nazione, che è poi quella più numerosa costituita dal mondo del lavoro, potrà impedire che qualche agguerrito hacker di Assange, o meglio qualche moderno emulo dell'antico scrittore di satire Giovenale, possa pronunciare l'anatema Omnia Romae in pretio, cioè: «A Roma tutto si compra».
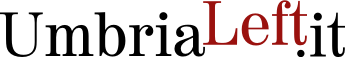



Recent comments
4 anni 50 weeks ago
5 anni 3 weeks ago
5 anni 3 weeks ago
5 anni 3 weeks ago
5 anni 4 weeks ago
5 anni 4 weeks ago
5 anni 4 weeks ago
5 anni 4 weeks ago
5 anni 5 weeks ago
5 anni 5 weeks ago