Il concerto di Bob Dylan (di Antonello Tacconi)

C’è sempre qualche cosa da imparare, o forse meglio da riscoprire in un concerto di Bob Dylan. Come ad esempio, per chi non lo facesse o lo avesse dimenticato, quello di ritornare a concentrarsi solo ed esclusivamente sulla musica e nient’altro di più. E la scelta dell’artista di far “imprigionare” i telefonini degli spettatori in apposite custodie chiuse mo’ di antitaccheggio andava proprio in questa direzione. Ovvero far parlare la musica e solo essa. E nemmeno il mito o la figura di Dylan doveva sovrastarla, proprio per sua stessa scelta. In tal senso la coreografia minimale rosso fuoco con faretti modello cinema che si “accendevano” sulle canzoni per poi spegnersi appena queste erano terminate, lasciando la band e lo stesso Bob in oscurità, andavano in questa direzione. Ovvero quella di un uomo che ha attraversato le varie epoche del secolo scorso e si è affacciato nel nuovo millennio con un mito e una figura forse talvolta sovrastanti lo stesso essere umano che è in lui. Un ruolo, come tante altre etichette spesso a lui affibbiate, che Dylan nei suoi sessant’anni di carriera ha sempre cercato sfuggire per offrire solo la sua arte e la sua poetica che ha “letto” sì la storia delle varie epoche che ha attraversato, ma per poi sempre cambiare direzione di marcia verso nuove esplorazioni, nuove letture, pur rimanendo ancorato alla più profonda tradizione musicale americana del blues, delle radici folk e di tanto tanto altro. Lo stesso puntuale inizio del concerto ed il modo con il quale l’artista si è piazzato sul palco era un altro inequivocabile segnale di questo messaggio.
Dylan entrava sul palco del Santa Giuliana seduto al piano e circondato dalla sua band, senza essere in primo piano ma con i musicisti intorno a lui quasi come a “proteggerlo” e creando una specie di isola musicale che era il solo centro della scena, con i maxischermi del palco rigorosamente spenti per togliere ancora di più il potere alla celebrazione dell’immagine, ma concentrando la dimensione sensoriale dello spettatore solo sul palco e sull’ascolto della musica.
E che musica! Chi si aspettava un concerto equamente diviso tra i brani più recenti ed i vecchi cavalli di battaglia, probabilmente resterà deluso della serata. Dicevamo però della musica. I brani cantati, infatti, provenivano quasi tutti dall’ultimo e fortunato album “Rough and Rowdy Ways”. Da questo infatti, infatti tratti la maggior parte dei brani, magistralmente suonati e soprattutto interpretati da un Dylan in splendida forma. Ed ecco allora gemme dell’ultimo disco, come la delicata “I contain multitudes” esempio di come ancora si possa fondere poesia e ballata intimista. E poi si virava verso l’altra anima di brani ancorati al più autentico blues delle origini, come ad esempio “False Prophet” ; “Crossing the Rubycon” o l’omaggio di “Goodbye Jimmy Reed”, tanto per citare qualche esempio. Sempre dell’ultimo discom, invece, si virava verso le atmosfere notturne di “ My Own Version of You” o la sognante “Mother of Muses”.
Ed il passato? Qui Dylan si è divertito a inserire delle gemme che hanno messo a dura prova la cultura dei più incalliti conoscitori del vasto canzoniere dell’uomo di Duluth. Alcune tirate fuori anche da album considerati non le migliori prove dello stesso Dylan. Pezzi che raramente o forse mai erano stati inseriti nelle scalette dei suoi concerti. Ed ecco allora spuntare una “When i Paint Masterpiece” che Dylan scrisse e poi fu ripresa da The Band nel 1971 nell’album Cahoot. Canzone, tra l’altro, che è entrata anche nel prossimo album in uscita “Shadow Kingdom”, dove il Nostro si diverte a dare nuovo abito ad alcuni suoi pezzi del passato.
Da un best seller come uno dei primi doppi album della storia, ovvero Blonde on Blonde, emerge invece una fantastica “Most Likely You Go Your Way and I’ll Go Mine” qui proposta in un mirabile abito nuovo ma che non ha del tutto reso irriconoscibile il brano musicale.
Ma c’è stato anche spazio per una "I’ll be your baby tonight" da "John Wesley Harding” e di “To be alone with you" da "Nashville Skyline”, per passare alla vivace "Gotta serve somebody" di "Slow train Coming" . Alla fine di questo sommario elenco citiamo l’alfa e l’omega dei due brani che hanno iniziato e concluso il concerto. Ovvero la blueseggiante Watching the River Flow in apertura della serata e la "Every grain of sand" da "Shot of love" con il quale Dylan ha chiuso la scaletta concedendo per l’entusiasmo dei presenti l’unico assolo di armonica, in una serata dove il pianoforte è stato l’unico strumento da lui suonato. E quando il pubblico si è alzato in piedi accorrendo sotto il palco per salutare Dylan e la sua formidabile band (Charlie Sexton e Bob Britt alle chitarre, Donnie Herron per steel guitar, violino e fisarmonica, Tony Garnier al basso e Matt Chamberlain alla batteria), lui ha ringraziato tutti. Per un attimo ha osservato la platea con i suoi occhi, sempre più piccole ma attente fessure per captare quello che accadeva. E quando forse ha compreso che l’applauso e le grida erano probabilmente più per la leggenda ed il mito che per la musica, si è ritirato senza concedere alcun bis. A noi, invece, è restata la sensazione di un qualcosa di unico, di irripetibile e fortunatamente non riproducibile perché scolpito nelle orecchie e nei cuori di chi si è voluto avvicinare solo all’arte di questo uomo che, nonostante le ottanta primavere superate, vuole ancora guardare il mondo con la sua sensibilità, la sua arte e visionarietà. Semplicemente Bob Dylan.
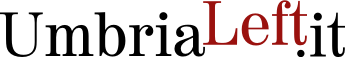



Recent comments
5 anni 37 weeks ago
5 anni 42 weeks ago
5 anni 43 weeks ago
5 anni 43 weeks ago
5 anni 43 weeks ago
5 anni 43 weeks ago
5 anni 44 weeks ago
5 anni 44 weeks ago
5 anni 44 weeks ago
5 anni 44 weeks ago