Crisi in Europa, emergenza in Italia

PERUGIA - da ilmanifesto.it
Trichet: in Europa la crisi è sistemica
Il Presidente uscente della Banca centrale europea (Bce), Jean Claude Trichet, ha dichiarato in un’audizione al Parlamento Ue che “la crisi, che ora è sistemica, nelle ultime tre settimane è peggiorata e le istituzioni devono agire rapidamente, senza ulteriori ritardi che altrimenti aggraveranno la situazione”.
Trichet ha preso atto che le iniziative europee (il “fondo salvastati”), del Fondo monetario internazionale (prestiti ai paesi in difficoltà) e i provvedimenti inusuali dell’Eurosistema (tra gli altri, acquisto di 60 miliardi di obbligazioni bancarie garantite e 75 miliardi di titoli di stato già prima di giugno; liquidità a rubinetto in euro, dollari sterline, yen e franchi svizzeri per tutti gli operatori finanziari; ulteriori massicci acquisti di titoli nelle ultime settimane) non sono stati sufficienti per riportare la fiducia sui mercati finanziari.
Non poteva essere altrimenti perché, con l’evidente perdita di credibilità nella sostenibilità delle finanze pubbliche di alcuni paesi, la crisi non si poteva risolvere soltanto mediante iniezioni di sempre maggiore liquidità. I capitali hanno lasciato la Grecia e stanno andando via dall’Italia; in Europa si dirigono verso gli stati più ricchi, nel mondo verso gli Stati uniti, paesi in cui il rendimento dei titoli di stato è sceso a livelli molto bassi nel confronto temporale.
La fuga dall’Europa si è trasformata in domanda di dollari e la moneta statunitense ha ritrovato l’antico monopolio come moneta internazionale di riserva. Nell’attivo della Federal Reserve, la banca centrale Usa, è aumentata la quantità di euro (che sono passività dell’Eurosistema) ceduti dagli operatori mondiali. La perdita di credibilità dell’economia del nostro paese e dei suoi governanti sta alimentando l’instabilità dell’intero sistema finanziario internazionale.
L’emergenza italiana e la lettera della Bce
Questo è il quadro drammatico in cui va letta la lettera del Presidente della Bce e del Governatore della Banca d’Italia al nostro governo; si tratta di una misura più che inusuale, irricevibile sul piano istituzionale in condizioni di normalità. Aldilà delle concrete misure sollecitate, molte delle quali non condivisibili, la lettera richiede due obiettivi non derogabili: il pareggio di bilancio e il rilancio dell’economia. Il corollario, non esplicitato, ma del tutto ovvio, è il cambio di governo.
Il pareggio di bilancio è forse un obiettivo insufficiente per ricreare un clima di fiducia negli investitori internazionali. Il debito ha superato i 1900 miliardi di euro, un valore che con le vecchie lire sarebbe stato impronunciabile e avrebbe avuto bisogno di 16 cifre per essere rappresentato (3.650.000.000.000.000 lire); il premio al rischio attribuito dal mercato ai titoli con durata superiore a un anno rimane ampiamente superiore ai tre punti percentuali a quello degli analoghi titoli tedeschi e di quasi un punto a quelli spagnoli. Se non ci saranno miglioramenti nella sostenibilità del debito, nel bilancio dello stato del prossimo anno gli interessi passivi aggiuntivi – che compensano il maggior rischio degli investitori - sarà dell’ordine di 25 miliardi, per oltre metà pagati all’estero. Si tratta di una “mezza manovra” in più, che vale un punto e mezzo di Pil, da ripetere ogni anno, riducendo altre spese pubbliche o aumentando le entrate fiscali. Con i vecchi titoli che vengono in scadenza, da rifinanziare con nuovo debito a tassi più alti, quest’aggravio di interessi passivi potrebbe raddoppiare in un triennio.
Quest’emergenza nei conti pubblici deve essere affrontata con una straordinaria, credibile ed equa politica di risanamento, che non può che avere al centro una nuova tassazione della ricchezza privata del paese, che in questi anni è cresciuta e si è concentrata nelle mani degli italiani più fortunati. Ma allo stesso tempo è essenziale una politica che faccia ripartire la crescita dell’economia, su binari diversi dal passato. Le potenzialità migliori sono nella direzione di una green economy che crei nuovi beni e servizi sostenibili sul piano ambientale in attività ad alta intensità di occupazione, e di un aumento della produttività e competitività delle imprese fondato su miglioramenti di qualità, anzichè sulla riduzione dei costi, quello del lavoro in particolare. Una crescita lungo tali direzioni consentirebbe di migliorare la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale del paese, riducendo la necessità di finanziare all’estero il nostro debito. In questo modo la “bolletta energetica” del paese potrebbe essere drasticamente ridotta. Occorre qui porsi obiettivi ambiziosi, ad esempio di portare entro il 2020 la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ad almeno il 70% del totale; gli edifici devono avere un rendimento energetico molto superiore all’attuale; va disincentivato ogni consumo superfluo di energia e di risorse naturali non rinnovabili, anche con un’adeguata tassazione ambientale. Tale politica avrebbe enormi potenzialità, sostituendo materie prime importate con investimenti moltiplicativi di reddito e capaci di creare nuova (e buona) occupazione.
In assenza di azioni di questo tipo, proseguirà l’agonia finanziaria dello stato, con il continuo drenaggio di risorse per il pagamento degli interessi (quello che Guido Viale definisce “default come processo”) oppure la dichiarazione d’insolvenza (“default come evento”). La prima prospettiva impoverisce progressivamente il paese fino all’epilogo di tragedia greca, la seconda presenta moltissimi rischi sul piano economico e sociale. In entrambi i casi, sarebbe falcidiata la ricchezza delle famiglie e delle imprese con effetti demoltiplicativi di reddito per il calo della domanda e precluso per molti anni l’accesso dello stato ai mercati finanziari internazionali; il crollo del sistema bancario minerebbe le fondamenta del circuito del credito e gli investimenti diventerebbero molto più difficili.
Oppure c’è la strada dell’uscita dall’euro e del ritorno della lira. Si tratta di un percorso inesplorato con molti rischi; il valore della lira rispetto alle altre monete internazionali sarebbe fissato ad un livello basso; le esportazioni dei beni ancora prodotti in Italia potrebbero crescere, ma tutte le merci importate avrebbero notevoli incrementi di prezzo, con rischi di inflazione e peggioramento dei redditi reali; il debito estero resterebbe denominato in euro e sarebbe più difficile da rimborsare; una fuga di capitali privati verso l’estero sarebbe probabile, peggiorando notevolmente i conti del paese e le possibilità di ripresa.
Draghi: l’Italia è troppo grande per fallire e troppo grande per essere salvata
Qualche giorno dopo le dichiarazioni di Trichet, nell’intervento d’apertura del convegno “L’Italia e l’economia internazionale, 1861-2011” organizzato dalla Banca centrale per celebrare i 150 anni dell’unità del nostro paese, il governatore uscente Mario Draghi ha ripercorso alcune tappe dello sviluppo economico italiano e ha mandato numerosi segnali. Otto i principali: l’Italia è troppo grande per uscire dalla crisi con gli aiuti dall’estero; la crisi è sistemica e l’Italia può contagiare l’intero sistema finanziario europeo; la stagnazione economica dell’ultimo decennio ha concorso significativamente all’esplodere della crisi; l’apertura internazionale del sistema economico in Europa e nel mondo sono processi che non possono essere fermati; la situazione è difficile ma non disperata; l’obiettivo del risanamento dei conti pubblici non può essere disgiunto dal rilancio dell’economia; per rilanciare l’economia occorre intaccare i privilegi di “gruppi sociali organizzati” stratificatisi in molteplici campi di attività; “Occorre agire con rapidità. È stato già perso troppo tempo”.
La difficile situazione attuale, tuttavia, è il risultato delle modalità con cui è stata realizzata l’Unione monetaria in Europa e delle risposte che sono venute da imprese, banche e governi. Prima dell’unificazione monetaria l’equilibrio tra le economie dei paesi europei si poteva realizzare attraverso la leva del cambio e delle svalutazioni. Quando si formava un disavanzo eccessivo nei pagamenti con l’estero, la riduzione del valore della moneta ripristinava la competitività delle imprese e nel volgere di qualche tempo l’equilibrio nei conti internazionali; ciò non era immune da conseguenze sul piano interno, perché l’aumento dei prezzi delle merci importate innescava un processo inflazionistico che a sua volta portava a effetti redistributivi e accentuava le tensioni sociali. I paesi con monete forti, capaci di attrarre capitali esteri, erano invece avvantaggiati da un costo del capitale più ridotto.
L’unificazione monetaria è stata un elemento centrale dell’Unione europea, che fu guidata da motivi ideologici e realizzata in pochi mesi per scongiurare il timore della ricostruzione di una Germania unificata forte e militarizzata; l’unione fu promossa senza adeguate riflessioni sulle conseguenze economiche e finanziarie in un mondo che andava mutando con una velocità senza precedenti.
Nelle intenzioni dei promotori, la moneta unica, oltre ad assumere un grande valore simbolico, avrebbe portato vantaggi nelle transazioni internazionali e accresciuto il ruolo dell’Europa nel mercato mondiale. Per evitare che squilibri nella situazione finanziaria di alcuni paesi potessero minare la solidità della moneta furono fissati blandi parametri di finanza pubblica, che però furono subito disattesi con l’inclusione dell’Italia fra i paesi aderenti.
Per i paesi con una moneta debole, si riteneva che l’euro consentisse di superare la trappola delle svalutazioni competitive e che la riduzione del costo del capitale dischiudesse la possibilità di avviare una politica economica espansiva, favorendo gli investimenti pubblici e privati e creasse le condizioni per il risanamento dei conti pubblici; l’attesa era di un aumento degli investimenti nelle infrastrutture, nei processi produttivi, nella qualità dei prodotti e nello sviluppo di nuovi beni e servizi; in tale prospettiva la perdita della sovranità nella politica monetaria non avrebbe costituito un handicap significativo.
L’occasione perduta dell’euro
La realtà è stata differente. La diminuzione del costo del capitale ha avuto sulle imprese l’effetto opposto. Ha incrementato il valore di mercato delle aziende e ha ridotto i capitali investiti nell’attività produttiva. In un contesto di rapida crescita della finanza internazionale, si sono moltiplicate le operazioni di ingegneria finanziaria fondate sull’indebitamento, consentito dai bassi tassi d’interesse, col risultato di sottrarre – paradossalmente – risorse agli investimenti reali e di alimentare i flussi internazionali di capitali, le attività speculative e i patrimoni personali di chi aveva la proprietà delle imprese. Le banche hanno finanziato tali fenomeni, moltiplicando le proprie attività, margini operativi e debiti, portando ad un sistema bancario più fragile, esposto all’instabilità della crisi attuale.
In Italia l’apparato produttivo è invecchiato per gli scarsi investimenti e sui mercati mondiali ha subito forti perdite di competitività. Interi settori produttivi nelle tecnologie più avanzate, dove le potenzialità di crescita sono maggiori, sono stati abbandonati. Invece che su politiche d’innovazione di prodotto e di processo, le imprese hanno puntato sulla riduzione del costo del lavoro e sulla delocalizzazione produttiva nei paesi emergenti per tentare di mantenere le posizioni. Tale scelta ha provocato un significativo peggioramento della situazione del lavoro, soprattutto per i più giovani: i salari reali si sono ridotti per la maggior parte dei lavoratori, i nuovi contratti di lavoro hanno alimentato la precarietà, le condizioni di lavoro sono peggiorate. Inoltre, ha favorito l’arrivo di lavoratori extracomunitari (sei milioni nell’ultimo decennio quando nei periodi precedenti l’immigrazione era un fenomeno del tutto marginale). Ne è risultato un generale impoverimento del paese.
Il “dividendo dell’euro” è stato così sprecato dalle imprese, ma anche i governi non hanno colto l’occasione dei bassi tassi d’interesse – e della migliore reputazione accumulata sui mercati internazionali con il programma di privatizzazioni degli anni ’90 - per mettere ordine nei conti dello stato e ridurre il debito pubblico. Gli aumenti delle spese correnti improduttive, l’allentamento dei controlli che hanno favorito evasione ed elusione fiscale e pratiche illecite, le riduzioni di alcune imposte e la cancellazione di altre – tra cui l’Ici e l’imposta di successione – hanno reso impossibile il risanamento dei conti pubblici: l’occasione dell’euro è stata così sprecata anche da parte dei governi.
La crisi del debito pubblico italiano s’inserisce dunque in un quadro di debolezza dell’intero sistema produttivo, con prospettive di ulteriore marginalizzazione. Da ultimo, la crisi si è accentuata per l’assenza di credibilità del governo e la tragica improvvisazione nel formulare coerenti piani di risanamento e rilancio. Nemmeno i recenti interventi dell’Eurosistema – Banca centrale europea e banche centrali nazionali - di sostegno al sistema bancario e al funzionamento dei mercati hanno ridotto incertezza e instabilità.
Si è di fronte a un dilemma difficile da risolvere: data la dimensione del debito, lo stato italiano è certo troppo grande per fallire. L’insolvenza italiana porterebbe a conseguenze inimmaginabili per l’Europa e per l’intero sistema finanziario mondiale: già ora nell’attivo delle banche centrali dell’Eurosistema la quota di titoli di stato sovrani è cresciuta in misura elevatissima; a sua volta la Bce è stata finanziata dalla Federal Reserve (la banca centrale americana) acquistando euro in grandi quantità. I titoli pubblici italiani hanno un peso notevole nei bilanci di molte banche europee e fondi d’investimento internazionali.
Ma l’Italia è anche troppo grande per essere salvata, date le attuali regole dell’Unione monetaria e della finanza. In Europa il “fondo salva-stati”, il più recente strumento in via di realizzazione per affrontare la crisi, dispone di risorse modeste a fronte delle dimensioni della crisi. Le regole di comportamento della Bce – già ampiamente stravolte in questi mesi – sono ancora vincolate all’obiettivo della stabilità dei prezzi (l’inflazione dovrebbe rimanere inferiore al 2%). Le divisioni tra i governi europei e l’assenza di una visione di lungo periodo minano la reputazione dell’Unione monetaria come un soggetto solidale e affidabile. Dall’altro lato, i mercati finanziari operano sulla base della piena liberta di movimento dei capitali, con strumenti speculativi difficili da monitorare e controllare (vendite allo scoperto, derivati, etc), senza una tassazione delle transazioni finanziarie e con regole insufficienti sulle attività bancarie e finanziarie.
In queste condizioni l’Europa – così com’è - non ha la strategia, gli strumenti e le risorse per salvare un paese grande come l’Italia. Per evitare il disastro, il sistema finanziario internazionale e l’Unione europea dovranno necessariamente cambiare. E necessariamente dovranno cambiare, in Italia, governo e programma di governo.
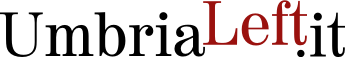



Recent comments
5 anni 1 settimana ago
5 anni 6 weeks ago
5 anni 7 weeks ago
5 anni 7 weeks ago
5 anni 7 weeks ago
5 anni 7 weeks ago
5 anni 8 weeks ago
5 anni 8 weeks ago
5 anni 8 weeks ago
5 anni 8 weeks ago