Era mio padre
di Nicola Capizzi
Palermo, 19 luglio 1992, ore 16,58. Un boato improvviso scuote la città. E’ un rumore che ricorda quello di un petardo, ma con un botto più forte e dirompente. E’ il rumore di 100 chili di tritolo che spazzano via tutto. E’ il rumore che dovevano sentire fino a Roma. E’ il rumore di sei vite spezzate.
Trapani, 19 luglio 1992. Una normale giornata d’estate fatta di caldo torrido, di mare e panini con le panelle consumati sulla spiaggia. Verso le 14 mia madre ci dice che è ora di tornare a casa che nel pomeriggio sarebbe venuto a trovarci un suo zio al quale lei era molto legata.
Intorno alle 16,30 il mio sonno pomeridiano viene interrotto dal trillo del telefono. Risponde mio padre, poche parole e via di corsa ad accendere il televisore. Mi avvicino a lui e gli chiedo spiegazioni. Mi chiedo perché il televisore fosse acceso a quell’orario, così strano per le nostre abitudini. Mio padre non mi dà retta e allora io insisto: “Papà che hai?” Mi osserva con uno sguardo strano, ha il volto tirato e gli occhi lucidi. L’espressione era simile a quella di un mese prima, del 23 maggio. Ma stavolta era cambiato qualcosa, tutto sembrava amplificato. Il suo volto era più triste e più rassegnato e le sue mani tremano più forte. Si gira a guardarmi pochi istanti per puntare nuovamente gli occhi sullo schermo. Mi seggo vicino a lui e osservo curioso le immagini che scorrono sul televisore. Sono immagini raccapriccianti anche per lo stomaco più forte, figurarsi per un bambino. Lo scenario sembra quello di Beirut. Ci sono macchine che bruciano e altre distrutte. E poi ancora: polizia, carabinieri, ambulanze e vigili del fuoco. Le riprese si susseguono copiose e il silenzio di mio padre mi mette tensione. Poi arriva mio fratello che sembra aver capito tutto. Lui ha sempre capito tutto. Lui è nato grande diceva mio padre. Capisco che è successo qualcosa simile al mese scorso, capisco che avevano freddato qualcuno. Mi prendo di coraggio e decido di romperlo quel silenzio. Con la semplicità di un bambino rinnovo la mia domanda ma con una formula diversa.
“Papà - gli faccio - hanno ammazzato un amico tuo?”. “Si, anche se non l’ho mai conosciuto”, mi risponde.
La confusione si fa ancora più forte, e quel chiarimento che mi aspettavo si fa meta sempre più irraggiungibile. Mi seggo sulle sue gambe, mi sentivo spaesato, davvero non sapevo che fare, davvero non sapevo che dire. “Papà - insisto - hanno ammazzato uno come quello di prima, perché fai così?” Di punto in bianco sembra riprendersi da uno stato catatonico. La naturalezza delle mie parole lo scuotono ulteriormente. Probabilmente avrà riflettuto sul fatto che era un’anomalia inaccettabile che un bambino viva con normalità una strage che ha visto morire servitori dello Stato. E già, lo Stato. Quell’istituzione strana a cui ha dato sempre un senso primario, un senso che va oltre il semplice ideale.
Quando fecero saltare in aria Falcone si limitò a dirmi giusto qualcosa su cosa fosse Cosa nostra. Giusto qualcosa per saziare, se pur in parte, la mia viscerale curiosità.
Nicoluccio ora ti spiego meglio cos’è la mafia. Inizia così a parlarmi degli uomini d’onore che di onorevole avevano poco, anzi nulla. Mi racconta delle sue lacrime alla morte di Piersanti Mattarella, di Pio La Torre, che era uomo giusto e per questo hanno pagato con la vita. Del coraggio e del senso del dovere di Carlo Alberto Dalla Chiesa e Boris Giuliano, che indossavano la divisa non per incutere timore ma per dare sicurezza. Ha aggiunto ulteriori dettagli all’attentato di Pizzolungo. Quella strage, di cui puntualmente mia madre mi parlava tutte le volte che passavamo davanti il parcheggio del tribunale di Trapani, dove dimorava dimenticato l’ammasso di ferraglie, dove viaggiavano Barbara Asta con i suoi figli gemelli. Della macchia di sangue che lordava il prospetto di un’abitazione adiacente la strada dove si è consumato il misfatto, che quella macchia era ciò che rimaneva di una famiglia distrutta. Aggiunse tante altre cose, ma ad oggi, i ricordi si fanno più confusi e non saprei che aggiungere.
A distanza di anni mi tornano in mente ricordi e frasi che possono apparire scollegati, ma che per me non lo sono affatto. Mi vengono in mente il ricordo di un passaggio della preghiera che mio padre scrisse, e lesse con voce tremante, il dì della nostra prima comunione. “Signore, fai che Giacomo e Nicola crescano nell’onestà. Fai che un giorno siano degni di essere chiamati figli nostri”. O le parole di mio fratello, che il giorno della dipartita di nostro padre mi strinse in un abbraccio avvolgente, e ad un orecchio mi sussurrò: “Rialzati, dobbiamo continuare quello che ha iniziato Papà. Ti ricordi cosa diceva sempre? Non è forte chi non cade mai ma chi cade e si rialza”.
L’eredità di mio padre è fatta dei suoi buoni insegnamenti. E' costellata di valori imprescindibili, di principi ferrei che per me sono ragion d'essere .
Le sue parole mi hanno fatto capire che Cosa nostra va combattuta con l'unica arma davvero intelligente: il sapere. Sapere che la mafia non è la normalità ma l'anomalia. Sapere che una vita con un lavoro dignitoso non può e non deve essere una concessione del mafioso o del politicante di turno ma un diritto. Sapere che lo Stato sono i cittadini e per questo va servito. E se spesso, o quasi sempre, non è così allora bisogna lottare affinché lo diventi. Sapere che, come diceva Giovanni Falcone, Cosa nostra è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine.
Bisogna parlare della mafia, continuamente, ovunque, soprattutto nelle scuole. Bisogna conoscerlo il nemico, se lo vuoi sconfiggere. Forse è proprio questa convinzione che mi ha portato a sposare la causa di Pino Maniàci e della sua, o meglio nostra, Telejato.
Dalle telecamere di questa piccola grande tv il suo direttore fa nomi e cognomi dei mafiosi, appellandoli come pezzi di merda. Una piccola emittente che negli anni, e con enormi sacrifici della famiglia Maniàci, è diventata un punto di rifermento per un territorio che abbraccia da Palermo a Partinico, passando per Corleone e San Giuseppe Jato. Grazie all'instancabile lavoro di Pino e dei suoi collaboratori molti imprenditori del comprensorio hanno denunciato i loro estorsori e intere famiglie mafiose spedite nel loro habitat naturale: le patrie galere. Al tritolo e alla lupara lui risponde con le sue armi: telecamera e microfono. Mi fermo qui, quella di Pino è un'altra storia.
Un'ultima cosa: Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, le vostre idee camminano con le nostre gambe.
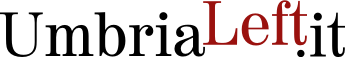



Recent comments
12 years 9 weeks ago
12 years 9 weeks ago
12 years 9 weeks ago
12 years 9 weeks ago
12 years 9 weeks ago
12 years 9 weeks ago
12 years 9 weeks ago
12 years 9 weeks ago
12 years 9 weeks ago
12 years 9 weeks ago