Rosina "Luxemburg", partigiana forte come un eroe omerico e dolce con i bambini.

di Elio Clero Bertoldi.
“Ho visto con i miei occhi. Un pugno, uno solo, indirizzato appena sopra gli occhi ed il vitello stramazzò al suolo... morto”.
Questa la testimonianza resa da Walkiria Terradura Vagnarelli, eugubina, combattente per la libertà. A portare quel colpo letale sull’animale, che doveva essere abbattuto per trasformarlo in carne da distribuire alla banda partigiana affamata e spossata da giorni e giorni di digiuno, non fu un eroe omerico, un Aiace od un Epeo, campione di pugilato e neppure un erculeo patriota. Fu una donna.
Si chiamava Rosina “Luxemburg” Panichi, perché il padre Samuele, ardente socialista e comandante partigiano, le aveva affibbiato il nome dell’eroina tedesca, Rosa Luxemburg, appunto, ammazzata dai Freikorps, più di venti anni prima. Il fratello di Rosina, Carlo, portava d’altronde il nome di un altro fiero oppositore della borghesia e del capitalismo, Karl Liebknecht, fondatore con la Luxemburg della “Lega di Spartaco”, torturato e assassinato pure lui nel 1919. Tanto per sottolineare la convinzione ideologica, profondamente vissuta, di Samuele.
Una Giunone, Rosina. Di una bellezza mediterranea. Capelli ed occhi scuri, grandi, corpo solido. L’unica delle partigiane della V Brigata Garibaldi, che non indossasse i più comodi pantaloni per la vita nella macchia, fatta di lunghi e rapidi spostamenti, di notti passate all’addiaccio o in una stalla, ma piuttosto camicia i larghi e una lunga ed ampia gonna. Il tutto - raccontava, lei stessa, spiegando la scelta dell’abbigliamento adottato - per non mostrare le sue forme generose, abbondanti.
Forte, piena di salute, istintiva. Rosina era in grado di sopportare, senza lamentarsi, gli strapazzi di camminate interminabili e di notti stressanti e insonni a fare il turno di guardia, come e più di un collega maschio. Chi l’ha conosciuta e frequentata, chi ha diviso con lei quella dura esperienza, la descrive allegra, pronta alla battuta, bestemmiatrice colorita. Da buona umbra. In questa regione, pure ricca di figure di grandi santi, la blasfemia non é di per se stessa un sintomo di spregio della religione, ma quasi un intercalare. Soprattutto in alcuni ambienti. Di certo Rosina non amava i preti. E lo dichiarava apertamente. Senza infingimenti. Salvava soltanto, dei sacerdoti del territorio (“Tutti falsi e conformisti”, assicurava), don Giuseppe Celli, parroco di Secchiano di Cagli. coraggioso oppositore del regime, portato via dai nazifascisti e di cui non si avevano più notizie (si seppe, poi, a guerra finita, che il canonico era stato condotto a Mauthausen e qui ucciso).
Una notte proprio una bestemmia salvò la vita a lei e alla compagna Walkiria. Le due ventenni - incaricate dal comando di battaglione di portare, in tutta urgenza, un importante messaggio ad una formazione partigiana composta completamente di slavi, fuggiti dai campi di concentramento italiani - avevano dimenticato di farsi dare la parola d’ordine. La notte, fonda e buia, non permetteva di farsi riconoscere a vista e quando una sentinella lanciò l’ “alt, chi va là” le partigiane, colte di sorpresa, inciamparono sul terreno scosceso e pieno di sassi. La Panichi scivolò e ruzzolò pesantemente, a terra. E nella caduta le sfuggì di bocca una colorita imprecazione. E lo slavo, ridendo: “Ah, ho capito. La figlia di Panichi... Vieni avanti”.
Possedeva, Rosina, una cavalla bianca - dal nome “Ribella” - che cavalcava a pelo, neanche fosse la squaw di una tribù pellerossa di Sioux o di Navajo. Sui monti e le vallate dell’alto Chiascio, dell’Eugubino-gualdese, del Buranese, tutti i contadini e gli abitanti dei paesi la conoscevano. E le volevano bene, anche, perché era come loro, una donna del popolo, sincera e altruista. Nello zaino, pesantissimo e pieno zeppo, custodiva di tutto: dalle aspirine e dagli sciroppi fino alla dinamite; dalle erbe medicinali (le raccoglieva personalmente e con quelle curava i compagni ammalati o feriti) ai caricatori di riserva; dagli indumenti di ricambio alle caramelle per i bambini. Quando giungeva nelle vicinanza di un casolare, magari sperduto tra le campagne, i piccini per primi le correvano incontro, come se stesse arrivando Babbo Natale. Nei primi tempi ai più piccoli portava in regalo pure dei giocattoli, usati o rimediati chissà dove e chissà come, ma poi essendosi resa conto di non poter accontentare tutti, aveva smesso. Non intendeva fare, come si dice in campagna, “figli e figliastri”. Di caramelle, tuttavia, non era mai sprovvista e ne distribuiva, per quanto possibile visti i tempi, a piene mani.
Le sofferenze ed i sacrifici, per tutti, rappresentavano il pane quotidiano di quei mesi terribili tra il settembre del 1943 e l’agosto del 1944. Ma, ovviamente, i sentimenti non erano andati in pensione e neppure riposti in un cassetto. Rosina provava una simpatia, sì, insomma, aveva un debole per uno dei suoi compagni, Marino, forse senza nemmeno dichiararlo. Walkiria, che la vide con gli occhi umidi quando qualcuno della banda riportò la notizia che il giovane era rimasto ferito in uno scontro a fuoco con i nazifascisti e si avvicinò all’amica per consolarla, si vide rispondere in modo brusco e crudo dalla compagna, orgogliosa e riservata: “Fatti i ... gli affari tuoi...”
Il suo sorriso, la sua allegria li perse quando il fratello Carlo, in famiglia “Lelo”, venne fucilato dai nazifascisti sull’Alpe della Luna. Rosina e il padre, appena fu possibile, raggiunsero il luogo dello scontro cruento. Alcuni contadini li portarono nel punto in cui avevano sepolto, alla meglio sotto poche palate di terra, due giovani, trovati morti e senza documenti addosso. La ragazza riconobbe il corpo dell’amato fratello, dalle calze di lana dai colori vivaci, che lei stessa gli aveva confezionato, ai ferri e con le rimanenze di gomitoli diversi, qualche settimana prima. Cadde in ginocchio accanto al corpo del congiunto martoriato dai colpi delle mitragliatrici, continuando a ripeterne il nomignolo. Narra Walkiria che, da quel momento, Rosina non rise più. E nessuno la sentì, da allora, farsi uscire di bocca una bestemmia.
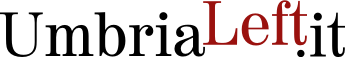



Recent comments
2 anni 31 weeks ago
3 anni 32 weeks ago
3 anni 33 weeks ago
3 anni 35 weeks ago
3 anni 35 weeks ago
3 anni 35 weeks ago
3 anni 35 weeks ago
3 anni 37 weeks ago
3 anni 37 weeks ago
3 anni 37 weeks ago