Perché lavori gratis per Zuckerberg.

di Daniele Gambetta - DinamoPress.
Il caso di Cambridge Analytica ha, tra i suoi meriti, quello di aver acceso il dibattito pubblico sull’utilizzo dei dati, quindi sul ruolo politico, delle piattaforme proprietarie dell’informazione. Nella naturale confusione generata dal clamore mediatico, e visto il poco sviluppo che negli anni hanno avuto questi temi sulle pagine dei giornali, sono emerse anche reazioni impulsive, spesso dettate da questo o quell’influencer, come l’ipotesi di boicottaggio del social network con la campagna #deletefacebook.
In realtà, quella della rinuncia all’utilizzo del servizio come segnale di protesta è un’ipotesi che, periodicamente e in circostanze particolari, rispunta fuori in spazi di critica anticapitalista, eventualmente accompagnata da valutazioni più morali che politiche. Allo stesso tempo, qualcuno ribatte (comunque adottando un punto di vista miope che non considera l’accumulazione originaria a monte) che chi accede ad una piattaforma accetta le condizioni previste, quindi anche quella di essere “sfruttato” dal colosso grazie al proprio lavoro messo a disposizione, e quindi che il gioco sia a somma zero.
Il punto, a proposito di produzione di informazione come lavoro, è che Facebook è soltanto la punta dell’iceberg. Un iceberg che sta emergendo dall’acqua trasformando drasticamente il paesaggio dei classici processi di produzione. Tutto il materiale condiviso su piattaforme proprietarie, o addirittura open, può essere utilizzato da terzi per compiere analisi dati o come materia prima per l’apprendimento automatico e lo sviluppo di intelligenza artificiale.
All’inizio del 2017, la Chan Zuckerberg Initiative (organizzazione filantropica fondata da Mark Zuckerberg e sua moglie Priscilla Chan) ha acquistato Meta, un sito specializzato nell’analisi di ricerche e pubblicazioni scientifiche grazie all’utilizzo di intelligenza artificiale. La fondazione si promette di accelerare i progressi scientifici e sostenere lo sviluppo tecnologico e medico, arrivando a «prevenire e gestire tutte le malattie entro la fine del secolo». Le grosse capacità di calcolo ed elaborazione dati possono consentire oggi a un colosso dell’informatica di fornire analisi in qualunque settore, potendo attingere non solo alle risorse del proprio recinto proprietario ma anche da fonti ad accesso aperto. Il 9 novembre 2015 Google ha rilasciato sotto licenza FOSS (Free and Open Source Software) la libreria per l’apprendimento automatico TensorFlow, sapendo così di poter usufruire di un contributo mondiale di una vasta comunità di programmatori. Per l’occasione, il CEO Sundar Pichai ha dichiarato: «Noi speriamo che questa scelta permetterà alla community del machine learning – ricercatori, ingegneri, amatori – di scambiare le idee più velocemente, attraverso il lavoro sul codice anziché soltanto su papers di ricerca».
È da notare che in entrambi i casi – Facebook Initiative e TensorFlow – la volontà estrattiva si traveste da capitalismo umanitario, nel quale il lavoro individuale diventa opportunità di contribuire al progresso.
Sempre restando nel campo della ricerca, c’è un altro caso interessante da considerare. Nel maggio del 2016, l’archivio accademico ad accesso (quasi) aperto SSRN ha annunciato che sarebbe stato acquistato da Elsevier. Il timore maggiore di molti ricercatori era quello di vedere i propri documenti diventare ad accesso chiuso o a pagamento, conoscendo le policy del più grande editore al mondo in ambito medico e scientifico. Come spiega Christopher M. Kelty in It’s the Data, Stupid, l’acquisto della piattaforma punta invece ad un nuovo modello, cioè poter utilizzare la mole di dati (e metadati) caricati dai ricercatori per sviluppare statistiche e modelli di impact factor da fornire poi come servizio a pagamento a università e centri di ricerca. Il mondo accademico che ci siamo costruiti, scrive Kelty, è un mondo in cui «un gran quantità di giudizi su qualità, reclutamento, avanzamento di carriera, conferimento di cattedre e premi è decisa da metriche poco trasparenti offerte da aziende a scopo di lucro». In tutto questo scenario poi si aggiunge il ruolo dei dati nello sviluppo di intelligenza artificiale e quindi nelle tecnologie di machine learning, che fanno dei dati il proprio petrolio.
Se siamo ricercatori, se carichiamo online musica da noi prodotta, se ci sottoponiamo a visite mediche che comportano elaborazione di nostri dati sanitari (eventualmente aggregati), stiamo in tutti questi casi contribuendo a una miriade di possibilità di estrazione di valore delle quali non verremo mai ricompensati né verremo a conoscenza. Inoltre, la diffusione sempre più capillare e pervasiva di tecnologie digitali, lascia intravedere un futuro in cui ogni tempo e spazio di vita sarà sempre più messo a valore senza una corrispettiva redistribuzione, e quindi senza una fuoriuscita alla precarietà, quanto invece nell’accentuarsi delle disparità economiche. Uscire da Facebook, per tornare alla questione principale, non va assolutamente a scalfire i meccanismi emergenti di forme di produzione, dal momento in cui un colosso dell’informazione, disponendo di grosse capacità di calcolo e di analisi, può trarre profitto da una vasta gamma di dati provenienti da varie fonti, non strettamente identificabili con il social network di cui è proprietario.
E QUINDI?
C’è un solo modo per smettere di lavorare gratis se per il momento non è possibile smettere di lavorare: farci pagare!
Riconoscere che il valore estratto in rete è già prodotto da un lavoro, e che il plusvalore relazionale costituisce l’input principale per il capitalismo contemporaneo, è fondamentale per elaborare una teoria sul reddito di base incondizionato che sappia essere attuale, come scrivono Andrea Fumagalli e Cristina Morini in un puntuale articolo pubblicato su Effimera:
Siamo tutte e tutti, nessuno escluso, “produttori di dati e di relazioni” che entrano in modo sempre più diretto nei processi di accumulazione capitalistica, o per via di espropriazione o per via di assoggettamento. La remunerazione simbolica tende a sostituirsi alla remunerazione monetaria.
Per questo è necessario ribadire che il reddito di base, lungi dall’essere forma di assistenza, è lo strumento della remunerazione del lavoro contemporaneo (relazionale e della cooperazione sociale) sfruttato – ora organizzandolo esplicitamente; ora in modo parassitario – dal biopotere del capitale.
A scanso di equivoci, il punto non è dichiarare che ci meritiamo un reddito perché produciamo dati tramite le piattaforme. Il reddito è un diritto di esistenza. Il capitalismo digitale cognitivo è semplicemente una lente di ingrandimento sui meccanismi di espropriazione del lavoro vivo immateriale, utile, in una fase come quella attuale, per rompere le argomentazioni delle tesi capitaliste, oltre che della sinistra lavorista. L’orizzonte, allora, diventa quello di portare un’argomentazione attuale alla richiesta di riappropriazione da parte dei lavoratori immateriali/prosumer non solo nei confronti delle quattro grosse piattaforme, ma rispetto a tutta la produzione di ricchezza, ormai resa possibile e concreta da tecnologie capaci di produrre valore dall’informazione. Nell’ottica invece successiva di creare tecnologie del comune, si deve ragionare di come costruire esperimenti di analisi e utilizzo dati che non siano per un profitto di pochi ma per creare un valore pubblico nei servizi di mobilità, salute e qualità della vita.
Parte di questo articolo è una rielaborazione dell’introduzione di Datacrazia – Politica, cultura algoritmica e conflitti al tempo dei big data, disponibile dal 10 aprile su deditore.com.
Sui temi affrontati nel testo discuteremo, insieme a Andrea Fumagalli, il 12 aprile a Pisa all’interno del festival K/NOW FUTURE, organizzato in occasione dei 5 anni di occupazione di Exploit.
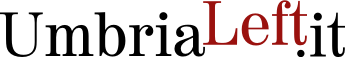



Recent comments
6 anni 11 weeks ago
6 anni 11 weeks ago
6 anni 12 weeks ago
6 anni 12 weeks ago
6 anni 12 weeks ago
6 anni 12 weeks ago
6 anni 13 weeks ago
6 anni 13 weeks ago
6 anni 13 weeks ago
6 anni 13 weeks ago