Medicina e medici dell’antica Roma

Di Maria Pellegrini
Una tragicomica iscrizione funebre latina recita così: “Morto di troppi medici”. Oggi i politici che annunciano tagli a prescrizioni di analisi e altre indagini specialistiche sarebbero pronti a scrivere sulle lapidi dei defunti: “morto di troppe prescrizioni mediche”. Dopo averci detto a più riprese che “prevenire è necessario”, ora i politici, sostituendosi ai medici, hanno stabilito che si ricorre troppo spesso a tali forme di controllo e prevenzione. Se talvolta ciò può essere vero, non si può accettare a cuor leggero che il risparmio per la spesa sanitaria sia ritenuto prioritario rispetto alla salute dei cittadini, e che siano i politici e non i medici a stabilire quale esame sia necessario per un loro paziente. È pur vero che i medici sono e sono stati spesso bersaglio di strali velenosi suggeriti anche da nostre speranze di salute disattese in seguito alle loro cure, ma non è un vizio di oggi “fare di tutt’erba un fascio”, perché anche nell’antica Roma la categoria dei medici fu spesso soggetta a critiche e a frecciate satiriche.
La medicina tardò ad affermarsi in Roma come disciplina propria, distaccata dal ruolo di pratica domestica. Nell’antica Roma repubblicana, fra le molteplici funzioni del “pater familias” - che assommava in sé l’autorità del giudice, dell’amministratore, del sacerdote - vi era anche quella della cura della salute del proprio gruppo familiare, schiavi compresi. Depositario di una lunga tradizione nella quale si intrecciavano superstizione, magia, credenze popolari, riti magico-religiosi, il “pater familias” esercitava la funzione di “curatore”, facendo ricorso a rimedi naturali, ma talvolta anche a formule magiche e alla preparazione di amuleti. Accanto alla medicina domestica esisteva anche una di tipo ieratico - praticata dai sacerdoti - che aveva ricevuto un forte impulso nel 292 a. C. quando nell’isola Tiberina fu costruito un tempio in onore di Esculapio, il dio greco della medicina. Il sacerdote-medico, la cui figura era utile alla casta sacerdotale per mantenere il suo prestigio contro il crescente potere delle altre classi sociali, offriva però rimedi molto simili a quelli del “pater familias”, basati su trattamenti ricavati dall’esperienza o su rituali magici.
A grandi linee si può suddividere la storia della medicina nella storia di Roma in tre periodi: il primo, legato all’antica medicina popolare degli Etruschi e degli altri popoli italici; il secondo, influenzato dalla penetrazione della cultura scientifica in seguito all’arrivo di medici greci a Roma nella metà del II secolo a. C.; il terzo, caratterizzato dal sorgere di vere e proprie scuole di medicina, a imitazione di quelle greche, con metodi e finalità diverse.
L’arrivo di medici greci a Roma nel corso del II sec. a.C. provocò la crisi delle due autorità tradizionali, il “pater familias” e il sacerdote ridimensionando il loro potere. Ma molti di questi medici giunti dalla Grecia a Roma e accolti come salvatori del genere umano, delusero sul piano professionale e morale, spesso rivelandosi ciarlatani o truffatori e provocando una reazione di difesa che indusse alla nostalgia del tempo antico, quando a Roma non vi erano medici professionisti. Plinio, vissuto al tempo di Vespasiano, cita l’esempio di Arcagato, il primo medico greco, giunto a Roma nel 218 a.C., al quale fu concesso il diritto di cittadinanza e insieme il permesso di gestire una bottega (“taberna”), oggi diremmo un ambulatorio, perché potesse svolgere la sua professione. All’inizio Arcagato fu molto apprezzato e salutato con l’appellativo di chirurgo (“vulnerarius”, colui che feriva). Ben presto, però, per la disinvoltura con la quale tagliava e bruciava, l’appellativo fu mutato in quello di “carnifex” (carnefice). Perciò, conclude sommariamente Plinio “vennero in odio la medicina e tutti i medici”.
Un aspetto assai nobile di Plinio a proposito della medicina - a parte la sua diffidenza nei confronti di essa -, è la riprovazione dell’utile economico ricavato sfruttando il terrore dell’uomo per le malattie e la morte. Ma ciò che più lo sconcerta e lo turba, è il fatto che la medicina sia in continua trasformazione, che ci siano diverse scuole in dissenso fra loro, e che i rimedi farmaceutici mutino continuamente a seconda delle mode venute da altri paesi. Del resto tale profonda diffidenza si rifà a Catone il quale, rivolto al figlio, secondo la citazione di Plinio, scriveva così: “Ti convincerò, o Marco, figlio mio, che quella dei medici è una genia perversa e incorreggibile. […] Essi hanno congiurato di ammazzare con i loro ritrovati tutti i barbari, cioè noi, che proprio loro chiamano barbari, ma lo fanno dietro pagamento, per ottenere fiducia e sterminare gli altri senza sforzo. […] Ti faccio solennemente divieto di ricorrere ad essi”.
Ma Catone aveva manifestato risolutamente il suo aspro dissenso nei confronti dell’intero mondo culturale greco. Plinio nutre la stessa avversione, anche se la sua cultura, come quella dello stesso Catone, è imbevuta di pensiero greco; tuttavia riguardo alla medicina, le sue critiche sono rivolte soprattutto all’etica e alla deontologia di essa, non tanto alle sue conoscenze specifiche.
Plinio non usa parole tenere nei confronti dei medici, definiti “mestieranti in cerca di fama con qualsiasi stramberia”, “cialtroni che speculano sulle malattie degli uomini” e che “al capezzale dei malati intraprendono meschine dispute, manifestando ognuno un parere diverso per non dare a vedere di condividere l’opinione altrui.” Con particolare sdegno si scaglia contro la ricchezza accumulata da alcuni di essi, diventati famosi regolando l’orario dei pasti dei pazienti sul movimento degli astri o consigliando ad essi, anche in età avanzata, di immergersi nell’acqua fredda persino nei mesi invernali; oppure inveisce contro la loro abilità nel parlare, grazie alla quale “diventano subito arbitri incontrastati della nostra vita e della nostra morte.”
Queste parole potrebbero essere valide , almeno in parte, ancora oggi quando si ha notizia di favolosi guadagni dei medici, delle loro divergenze cliniche che disorientano il malato, o dell’accanimento terapeutico per mantenere in vita quanti, ormai moribondi, sarebbe opportuno abbandonare al sonno eterno della morte.
A conferma dell’attaccamento di Plinio alla tradizione, ci sono nella sua opera molte allusioni con rimpianto ai tempi antichi nei quali a Roma la cura della salute trovava nella natura i rimedi più appropriati ad ogni malattia. Il suo intento è convincere l’uomo a diffidare dei medici e a tornare alla tradizione naturalistica trovando in essa i rimedi contro le numerose malattie che lo affliggono.
Nella sua voluminosa opera, “Storia naturale”, passa in rassegna il mondo vegetale e animale seguendo il principio dell’utilità, per raccogliere a beneficio dei contemporanei e dei posteri i rimedi escogitati nel lungo corso degli anni per caso o facendo tesoro di esperienze empiriche. A lui sembra che la natura abbia creato i numerosi vegetali e animali che popolano la terra proprio perché l’uomo potesse beneficiarne. Travolti da una valanga di notizie e da lunghi ma interessanti elenchi di virtù medicamentose tratte dal mondo vegetale, è necessario rimandare i nostri lettori, interessati all’argomento, alla diretta consultazione del testo pliniano, dal quale possiamo dedurre che anche l’erboristeria e la medicina omeopatica, affermatasi nel nostro mondo nell’ultimi anni, hanno radici antiche. Plinio privilegia anzitutto le ricette medicamentose basate sulle piante selvatiche da preferire a quelle coltivate perché in esse le virtù terapeutiche sarebbero più efficaci; “la stessa pianta, del resto - egli scrive - può servire a usi curativi opposti, se trattata e usata in modo diverso: cruda o cotta, macerata nell’aceto o mescolata al miele, presa a digiuno o a fine pasto. Variando poi la quantità, si evidenzia il fatto che una stessa erba, o ortaggio, o succo estratto incidendo la corteccia di un albero, abbiano anche effetti diversi, e talora opposti: possono essere digestivi, o provocare il vomito, placare o eccitare i sensi, stimolare l’appetito o placarlo”.
Ma già al tempo di Nerone, l’autore del “Satyricon”, Petronio, sembra preferire il ricorso a cure naturali e non nutrire tanta fiducia nell’operato dei medici, come si deduce da una frase detta da Trimalcione, personaggio e anfitrione della famosa Cena descritta nell’opera. Arrivato tra i convitati, egli si lava le mani con una lozione profumata e poi rivolto ai commensali, dice: “Cari amici, perdonatemi, ma già da un po’ di giorni non vado di corpo e i medici non ci capiscono nulla. Tuttavia mi hanno fatto abbastanza bene la scorza di melagrana e l’infuso di resina all’aceto, e spero che il mio intestino torni a fare il suo dignitoso servizio”. Durante le varie conversazioni con gli ospiti lamenta la morte di un amico con parole filosofiche sulla sorte dell’uomo, ma incolpa i medici: “Quel povero diavolo di Crisanto, un vero gentiluomo, se n'è andato e mi aveva fatto chiamare un attimo prima. Mi sembra ancora di averlo qui davanti che parliamo. Mah! Siamo otri gonfiati che camminano. Siamo meno delle mosche, che almeno un po’ di vitalità ce l’hanno, mentre noi non siamo altro che bolle. E se il poveretto non avesse fatto la dieta terribile che sappiamo? È andato avanti cinque giorni senza inghiottire una goccia d’acqua o una briciola di pane. Eppure è finito nel mondo dei più. La sua morte ce l’hanno sulla coscienza i medici”.
Ma fu soprattutto Marziale, che visse al tempo degli imperatori Flavi a lanciare frecciate velenose contro i medici. Riportiamo qualcuno dei suoi epigrammi:
“Ero malato, e tu Simmaco venisti a me coi cento tuoi discepoli: cento mani gelate dalla tramontana mi toccarono: io non avevo febbre. Ora ce l’ho”.
“Diaulo era un medico, ora è becchino: quel che ora fa da becchino, già lo fece da medico.”
“Ha fatto il bagno con noi, ha cenato di buon umore, ed ecco stamane Andragora è stato ritrovato stecchito. La causa d’una morte sì repentina mi chiedi, Faustino? In sogno gli apparve Ermòcrate, il dottore”.
“Erode, il dottore, ruba una tazza ad un infermo: Colto sul fatto dice: Sciocco, a cosa ti serve ora bere?”
Va comunque detto che tra i medici venuti a Roma, molti furono apprezzati per serietà e preparazione, tanto che Cesare concesse loro la cittadinanza romana; ad Antonio Musa, medico personale di Augusto, fu addirittura dedicata una statua sul Palatino. In età imperiale i medici riuscirono a ottenere il riconoscimento del loro status, per il quale da lungo tempo lottavano. Sotto Vespasiano l’insegnamento della medicina era addirittura riconosciuto dallo Stato e agli insegnanti era corrisposto, come per altre discipline, uno stipendio. L’unico romano tra i medici che operarono a Roma fu Celso (14 a.C.- 37 d.C.) autore di una sorta di enciclopedia medica “De medicina” in cui trattò di argomenti di chirurgia, di medicina. Descrisse i sintomi delle malattie in modo molto accurato tanto da potervi riconoscere disturbi noti e conosciuti anche ai nostri giorni. Ma il medico più importante dell’epoca romana, che lasciò una traccia importantissima nella cultura occidentale, fu Galeno (129 d.C.-200 d.C.). Nato a Pergamo, trascorse a Roma la maggior parte della sua vita e fu medico di Marco Aurelio, di suo figlio Commodo e di Settimio Severo. Le opere di Galeno costituirono il fondamento di tutta la produzione medica successiva.
Nella foto: intervento chirurgico su un soldato. Da una pittura murale di Pompei.
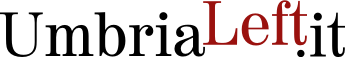



Recent comments
6 anni 12 weeks ago
6 anni 12 weeks ago
6 anni 13 weeks ago
6 anni 13 weeks ago
6 anni 13 weeks ago
6 anni 14 weeks ago
6 anni 14 weeks ago
6 anni 14 weeks ago
6 anni 14 weeks ago
6 anni 14 weeks ago